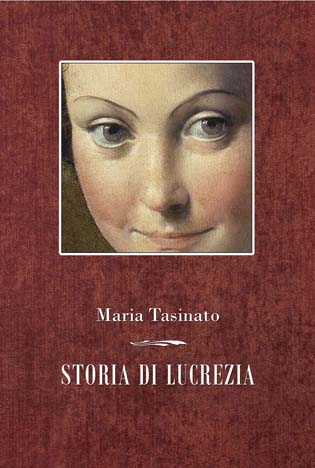Uno di loro, un loro profeta, aveva detto: “I Cretesi mentono sempre, bestiacce, ventri fannulloni”. Questa testimonianza è veritiera.
Ma chi sta denigrando così pesantemente i poveri abitanti di Creta? Lo fa San Paolo, lasciando ad un suo fido collaboratore, Tito, il compito di organizzare le comunità cristiane nell’isola.
Si tratta, infatti, dei versetti 12 e 13 del primo capitolo della lettera paolina a Tito.
San Paolo, in particolare, riferisce la sentenza di un illustre sapiente cretese, Epimenide, e lo fa, tra l’altro, senza dar gran peso ad un grossissimo problema che, suo malgrado, sottintende e scatena. Sto parlando di un insidiosissimo cul de sac: il famigerato Paradosso del mentitore.
Epimenide, in particolare, è Cretese e, in quanto tale, si presume che dica sempre il falso ma, se dicesse il vero, dando dei bugiardi agli altri Cretesi, allora che Cretese e che bugiardo sarebbe? Sarebbe un bugiardo che talora non mente. In ogni caso, ne seguirebbe, appunto, una contraddizione bella e buona.
Insomma, direbbero i filosofi, avremmo un’antinomia. E coi fiocchi, aggiungo io!
Ora – non preoccupatevi – non ho nessunissima intenzione di arenarmi, nonché di farvi venire l’emicrania e sicuramente di annoiarvi, con tale rompicapo, che ha fatto tremare le vene ai polsi a tanti logici di vaglia fino ai primi del ‘900, perché quello che mi preoccupa è, piuttosto, riscattare la reputazione dei Cretesi.
E ci tengo a farlo specie dopo un mio recente viaggio a Creta, in cui son rimasta assai colpita dal carattere oltremodo generoso e ospitale dei Cretesi, carattere che nemmeno il turismo massiccio degli ultimi anni è riuscito a mandare in frantumi. Ah, fossero anche solo lontanamente di questa pasta i Veneziani o i Fiorentini!!!
Ma vi è un motivo più profondo che mi spinge a parlar bene degli abitanti di Creta, ivi compresi quelli più antichi, e persino quelli mitici, ovvero la mia maniacale fissazione coi poemi omerici.
Mi limiterò all’Odissea. Ebbene, tutte le volte che Ulisse imbastisce un racconto ben congegnato per non rivelare chi egli sia, guardacaso, si finge un Cretese.
Ulisse lo fa la prima volta con la dea Atena; gli ospitali Feaci l’hanno appena deposto, profondamente addormentato, in una ridente insenatura di Itaca (il porto di Forco) e se ne sono ripartiti, prima che il dormiente abbia avuto modo di risvegliarsi. Dopo un po’, Ulisse si desta, ma non riconosce la terra dei padri perché Atena gli ha velato gli occhi con della nebbia, in modo che ciò che lo circonda gli appaia ignoto.
La dea ha fatto questo perché vuole parlargli per prima ed istigarlo a non manifestarsi subito ai suoi compatrioti e ai suoi servitori, e nemmeno a Penelope, al fine di mettere alla prova la loro fedeltà e, inoltre, per permettergli di punire i pretendenti della consorte.
Atena prende le sembianze di un leggiadro e cortese pastorello di stirpe regale. Alla mascherata divina, Ulisse risponde con un travestimento verbale, che precede il travestimento somatico che di lì a poco subirà per mano di Atena, la quale lo trasformerà in un vecchio e miserabile accattone, rendendolo completamente irriconoscibile.
Insomma, Ulisse, per il momento non ancora sfigurato, racconta di essere un Cretese venuto a contesa, fino ad ucciderlo, con il figlio del signore di Creta, il potente Idomeneo, nipote di Minosse, a sua volta, generato da Zeus (Iliade, XIII, 449-453). Ed è per sfuggire alle conseguenze di un omicidio così in alto loco che Ulisse, sempre seguendo le fila del suo racconto menzognero, è poi stato abbandonato sulle sponde di Itaca da certi Fenici, cui aveva chiesto protezione e rifugio (Od. XIII, 256-286).
Atena, manifestandosi alfine ad Ulisse, rimprovera benevolmente il suo protetto per la sua furbizia inveterata e per la sua passione indomabile per i racconti bugiardi.
Questa storia “cretese” è la meno complessa delle tre, egualmente “cretesi”.
Nella seconda storia, che è la più lunga, Ulisse, ormai trasformato in uno squallido mendicante, narra al fido porcaro Eumeo, che finisce per credere alle sue bubbole, di essere un figlio bastardo del re Idomeneo e infioretta abbondantemente la vicenda con scorrerie di predoni e di pirati, i quali lo hanno venduto schiavo (Od. XIV, 199-359).
Nella terza storia, ammannita a Penelope (che, pure lei, prende per buona), abbiamo un Ulisse che si dice informatissimo sulla composizione etnica degli abitanti di Creta, che sarebbero un mix di varie stirpi che si esprimono in più parlate. E, come ciliegina, in un crescendo di millanterie nobiliari, si proclama addirittura fratello minore di Idomeneo (Od. XIX, 165-202).
(Sorvolo sul fatto che Itaca, se non fosse per la fama conferitale dall’Odissea, sarebbe rimasta un’isoletta qualunque, mentre molto più illustre era Creta, isola che, tra l’altro, vanta d’aver dato i natali nientemeno che a Zeus!).
Inoltre ci sarebbe da aprire una lunga parentesi sulle bugie di Ulisse, perché, ad analizzarle bene, si scopre che Ulisse molto spesso non mente perché vi è costretto per causa di forza maggiore. Certo, mente indubbiamente per necessità con Polifemo, cui dice di chiamarsi Nessuno, per salvare la sua vita e quella dei compagni rimasti ancora vivi (Od. IX, 366-367), tuttavia, dall’eccessivo rigoglio dei suoi racconti “cretesi”, si deduce che Ulisse prova un piacere matto a mentire, tanto da non potersi trattenere dal farlo quando potrebbe benissimo farne a meno.
La prova provata l’abbiamo proprio alla fine dell’Odissea in una spiacevole scena in cui Ulisse mente spudoratamente al suo vecchio padre, Laerte.
Il cantore dell’Odissea ci propina la solita scusa: quella che Ulisse voleva “mettere alla prova” l’affetto paterno. Mettere alla prova un padre addoloratissimo per la lunga assenza di suo figlio?
Non dimentichiamo che Ulisse ha precedentemente incontrato nell’Ade la madre Anticlea, morta di crepacuore per non averlo più visto tornare. Ebbene, la defunta madre aveva rivelato al figlio che Laerte, ritiratosi negletto in campagna, lo attendeva sempre angustiatissimo (Od. XI, 187-203).
No, questa storia non sta proprio in piedi. Inoltre, tale alibi non regge anche perché ormai Ulisse non ha più alcun bisogno di restare in incognito, visto che i pretendenti della consorte sono già stati tutti sterminati.
Tuttavia, Ulisse non sa porsi un freno e inventa una storia strampalata, fingendosi proveniente, non da Creta questa volta, bensì da una località di fantasia, terra dove, anni addietro, lo stesso Ulisse sarebbe stato ospitato.
Al che, al povero Laerte sta per venire un colpo: gli si obnubila la vista e il misero si cosparge di fuliggine il capo gemendo cupamente. Solo allora Ulisse ha finalmente pietà dello sventurato genitore e lo abbraccia facendosi riconoscere (Od. XXIV, 244-326).
Ebbene, noi che, dopo secoli e secoli, leggiamo ora questa scena, non possiamo non indignarci – uso il “noi” perché non sono la sola a sdegnarmi – per tanto gratuito sadismo.
Insomma, c’è poco da fare: Ulisse mente soprattutto per il piacere di mentire, perché proprio questo, a mio parere, caratterizza il bugiardo… quello verace…
(Tra parentesi, l’incontenibile amore per la menzogna di Ulisse stende un velo di sospetto su tutto quello che Ulisse racconta in flash-back ai Feaci: chi ci garantisce che non si sia inventato di sana pianta le sue mirabolanti avventure?).
Ho fatto questa lunga divagazione sulle sevizie psicologiche inflitte gratuitamente al povero Laerte per mostrare come nemmeno chi cantò Ulisse, e ne consacrò così la fama imperitura, scelse di nascondere sempre i lati più “neri” dell’eroe dell’Odissea.
A questo punto, mi sorge uno strano sospetto che proverò a formulare, correndo il rischio che voi mi diate della pazza furiosa.
Domandiamoci: perché quando Ulisse mente in maniera particolarmente clamorosa spesso si finge un Cretese?
Ossia perché nei molti versi dedicati a quelle tre storie intricate, quanto bugiarde, vi è proprio Creta quale scaturigine della menzogna?
O, meglio ancora, chi ci vieta di vedere, sempre in quei versi, il terreno di coltura di quello che diverrà in seguito il paradosso del mentitore, che ha come attori principali i poveri Cretesi?
Invece di rispondervi subito, faccio una divagazione per parlarvi del grande stupore che provai lo scorso mese di maggio nel visitare Cnosso e, subito dopo, il ricchissimo museo di Iraclio.
Tutti m’avevano parlato malissimo di quegli scavi perché troppo ricostruiti, perché troppo colorati, perché troppo maledettamente hollywoodiani. Insomma, tutti mi predicevano che tanto Kitsch mi avrebbe senz’altro delusa.
Invece no – sarà che m’ero preparata da tempo al peggio – rimasi senza parole davanti alle copie degli affreschi che c’erano qua e là sulle pareti dei palazzi e dei propilei. Avevo un bel ripetermi che, quelle colonne – ahimè di cemento – erano probabilmente troppo scarlatte, quegli splendidi delfini, quei fiori lanceolati e quegli alteri portatori di vasi erano stati rifatti cedendo all’arbitrio ma, poco da fare, ne rimasi affascinatissima.
Quando poi mi trovai al cospetto del Principe dei gigli, di cui avevo visto tante volte la riproduzione, rimasi letteralmente senza fiato.
Un mio amico di lunga data, cui cercai invano di comunicare in presa diretta, via WhatsApp, il mio perdimento, mi rispose con perfidia che stavo reagendo, come già avevo fatto l’anno prima in presenza all’Hermes di Prassitele, ossia con l’entusiasmo tipico della “turista tardona” davanti alle belle forme d’un giovinetto.
E va bene sono una tardona – compio in questi giorni 69 anni – ma qual è il problema? Come si può non ammirare la gioventù, specie quando la si è perduta per sempre e da un bel pezzo?
Ma, in ambo i casi – per l’Hermes che sta ad Olimpia e per il Principe in quel di Cnosso – non abbiamo uno sfoggio della semplice gioventù, bensì di una gioventù che trasuda grazia, gentilezza e insieme un’estrema eleganza.
Quanto alla “turista”, beh, sinceramente, non mi sento tale. Ossia, amo troppo i poemi omerici per percepirmi solo come una semplice turista.
Ma che c’entrano i poemi omerici con Cnosso, mi direte? C’entrano, c’entrano eccome! E presto lo vedrete.
Ecco, vi mostro qui una foto – ahimè bruttina – che scattai, purtroppo ostacolata da una folla indiscreta di vari intrusi, ossia da turisti, loro sì.
Il giorno dopo mi recai al museo di Iraclio (dove fare foto era proibito) e dove potei constatare che dell’affresco – sarebbe più corretto parlare di un bassorilievo di stucco colorato – originale del Principe non restava molto. Ma, anche da quello che si poteva vedere senza aggiunte, risaltavano intatti certi inequivocabili particolari da capogiro: ad esempio, il perfetto contorno dei glutei e la squisita attaccatura delle cosce.
Devo perciò, d’ora in avanti, mio malgrado, ricorrere a immagini di repertorio.
Ma prima di giungere alla sala dove stava il Principe, mi soffermai a lungo in tutte le altre sale, dove, in teche innumerevoli, stavano disposte miriadi di oggetti – tra cui moltissimi gioielli – di una raffinatezza infinita, taluni antichissimi, risalenti fin al Neolitico.
E guardando, ad esempio, sia i castoni degli anelli e i sigilli, sovente piccolissimi, con rilievi cesellati finemente, e ammirando in seguito le statuine e gli affreschi mi accorsi che mancava qualsiasi scena violenta. Mai si vedeva un uomo con un’arma in mano nell’atto di colpire un altro uomo, ma nemmeno un animale, perché non solo le scene di guerra erano assenti, ma financo quelle di caccia risultavano bandite.
Ad un certo punto, un campanellino cominciò a suonarmi nella testa, dapprima in sordina poi sempre più squillante. E non potei non ascoltarlo allorché mi trovai dinanzi alla famosa sequenza dipinta in cui si vedono tre figure umane, in tre momenti diversi di una spericolata acrobazia su di un toro.
Un’acrobazia che non è certo una tauromachia:
Vi è una prima figura che sta per lanciarsi e afferra il toro per le corna, una seconda silhouette che, in equilibrio sulle braccia e con le gambe all’insù, sta sulla schiena dell’animale e infine una terza che è appena felicemente atterrata incolume.
Ora, non m’interessa discutere se si tratti di figure maschili o femminili – probabilmente la prima e la terza sono donne e quella mediana è un uomo – perché quello che m’affascina è l’estrema agilità e insieme l’estrema eleganza di tale volteggiare.
E qui ebbi appieno l’illuminazione che mi si era già preannunciata guardando il soave incedere del Principe: perché quelle che si intravedono, persino senza le varie ricostruzioni, non sono solo movenze di semplici atleti ma quasi quelle di ballerini.
Ora, se già nell’Iliade (XVIII, 590-605), nella descrizione dello scudo di Achille, si allude a splendide coreografie cretesi, indovinate dove nell’Odissea si parla di abili atleti e di squisiti danzatori? Se ne parla a proposito di un popolo non guerriero, amante degli sport leggeri ma anche del lusso. Ecco come definisce quel popolo il loro sovrano:
Noi non siamo infatti perfetti pugilatori e lottatori neppure, nella corsa siamo veloci e a navigare i migliori. Amiamo il banchetto, la cetra, le danze, cambiar le vesti, i caldi lavacri, l’amore (Od. VIII, 246-249) *.
Spero che almeno qualcuno di voi, leggendo questi versi, si stia ricordando che a parlare è Alcinoo, il re dei Feaci.
Ora, i Feaci, all’interno dell’Odissea, sono un popolo utopico agli antipodi dei popoli guerrieri quali vengono cantati nei poemi omerici, ossia gli Achei ma anche gli stessi Troiani.
I Feaci amano la vita elegante, sono una sorta di dandies dell’Odissea.
Ebbene, anche gli affreschi di Cnosso e le suppellettili del museo di Iraclio evocano un mondo estremamente raffinato, quale intuiamo fosse quello della “Grecia prima della Grecia”: così definiva genialmente Creta il grande Salvatore Quasimodo.
Un mondo che, in seguito, verrà – ahinoi! – per sempre perduto.
I Feaci sono esperti nell’arte della navigazione, ma anche i Cretesi lo sono. Insomma, quello che voglio azzardare è che chi cantò l’Odissea proiettò sui poveri Cretesi il lato più ambiguo di Ulisse, nella fattispecie il suo amore sviscerato per la menzogna, e tacque a bella posta sulle raffinatezze della civiltà cretese.
Certo quando germinarono i poemi omerici il mondo minoico era già finito da bel un pezzo, ma non poteva non essere arrivata, come un’onda lunga, la memoria di come si viveva in maniera raffinata a Creta. E tanto fasto, tanto saper vivere, vennero trasferiti in un popolo perfetto, un popolo, però, di fantasia: i Feaci, per l’appunto.
Vi sembra una completa pazzia? Beh andate a Cnosso e poi al museo di Iraclio sempre con l’Odissea nel vostro zainetto, come ho fatto io, e rileggetevi soprattutto l’ottavo libro e poi sappiatemi dire.
Precisazioni
* Nelle pitture di Cnosso, incontriamo anche due pugili, ma dai loro gesti, oltre che dalle loro silhouettes, non sprizza alcuna aggressività, anzi sono pieni grazia, tanto che sembra che stiano danzando.
La presenza di cetre è testimoniata dalle scritture geroglifiche cretesi e dalle impronte dei sigilli.
La traduzione di Od. VIII, 246-249 è di Maria Grazia Ciani.
Bibliografia essenzialissima
-Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, I, 109-115 (su Epimenide, ma senza il paradosso del mentitore); II, 108 (su Eubulide di Mileto, con un accenno minimo al paradosso del mentitore).
– W. Stanley Moss, Brutti incontri al chiaro di luna. Il rapimento del Generale Kreipe, traduzione di Gianni Pannofino, Milano, Adelphi, 2018, edizione inglese originale 1950 (vi si racconta un’audace impresa di Patrick Leigh Fermor (Scrittura di viaggio) durante la Seconda guerra mondiale; ci rende anche più familiare l’orografia di Creta).
– Christopher Somerville, Lo scalino d’oro. Viaggio a piedi nel cuore di Creta, traduzione italiana di Gian Luigi Giacone, Torino, EDI, 2009, edizione inglese originale 2007 (sull’ospitalità cretese odierna; San Paolo, invece, trovava da dire sul senso di ospitalità cretese: Tito, I, 8).
– Mario Lavagetto, La cicatrice di Montaigne: sulla bugia in letteratura, Torino, Einaudi, 1992 (soprattutto il primo capitolo dedicato alle menzogne di Ulisse: Un viaggiatore senza testimoni).
– Carlo Diano, La poetica dei Feaci, in Saggezza e Poetiche degli Antichi, Venezia, Neri Pozza, 1968.
– Salvatore Quasimodo, Minotauro a Cnosso, in La terra impareggiabile, Milano, Mondadori, 1958.
Ringrazio di cuore il mio amico Renato D’Antiga per avermi fatto rileggere questa mirabile poesia, che così comincia: “I giovani di Creta avevano \ vita sottile e fianchi rotondi”…
Postilla
Chi volesse rendersi conto delle caratteristiche dell’antica civiltà cretese e delle varie scoperte archeologiche che la riguardano può leggere con profitto: Paul Faure, La vita quotidiana a Creta ai tempi di Minosse, traduzione italiana di Rosanna Pelà, Milano, Rizzoli, 2018 (edizione francese originale 1973).
Un discorso a parte merita un altro libro dello stesso autore: Ulisse il Cretese (XIII secolo a. C.), traduzione italiana di Cesare Scarton, Roma, Salerno Editrice, 1985 (edizione francese originale 1980), che ho voluto leggere a bella posta solo dopo aver concepito e scritto Perché parlar male dei Cretesi?. Temevo, infatti, che le mie ipotesi interpretative, che restano e vogliono restare quelle di una dilettante e non certo quelle di chi sa di archeologia, perdessero la freschezza delle prime intuizioni che ebbi visitando Cnosso e il museo di Iraclio con l’Odissea nello zaino. Ebbene, adesso vi posso dire che, leggendo in seguito, e con gran trepidazione, il libro di Faure, non ho mai trovato nulla che ci faccia vedere i Feaci come prestanome dei Cretesi.