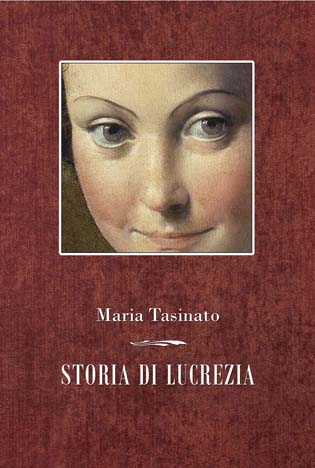PREMESSA
Quello che state per leggere uscì in due puntate (nei mesi di marzo e luglio 2021) nel “San Michele”, ossia nel Bollettino della chiesa di Sant’Agostino dei Boschi, già nel comune di Granaglione, ora Alto Reno Terme, in provincia di Bologna. Per la cronaca, la valle del torrente Randaragna (affluente del Reno, dove è ambientata gran parte della vicenda), si divide in cinque quartieri che, a loro volta, comprendono più borgate.
Scrissi questa storia soprattutto per divertire gli abitanti e gli oriundi di questo remoto recesso degli Appennini, dove nacque la mia nonna paterna. Perciò, è a costoro che mi rivolgo direttamente, ma anche chi non condivide la mia provenienza può leggere senza problemi. Infatti, l’idioma tosco-emiliano, detto “boscaiolo”, che talora vi fa capolino, è perfettamente comprensibile a chiunque parli italiano. Al testo del 2021, qui riprodotto quasi integralmente, ho solo aggiunto una Appendice per far intravedere un seguito, svoltosi negli anni immediatamente precedenti la Prima guerra mondiale, in terra veneta.
LA CASA NOVA
Quando da ragazzina giravo da sola a piedi per la nostra valle passando per i vari borghi, capitava spesso che una vecchina mi domandasse perentoria: “Di chi ssé-tu?”.
Tale richiesta, che tanto m’intimidiva, riecheggia uno dei versi più famosi di Dante, quando nel decimo canto dell’Inferno (v. 42), Farinata degli Uberti domanda a Dante la medesima cosa: “chi fuor li maggior tui? (chi furono i tuoi avi)”. Si tratta di un rituale antichissimo che affonda le sue radici fin nei poemi omerici, quando un eroe, sul campo di battaglia, chiedeva al nemico, prima di affrontarlo, quale fosse la sua stirpe (Iliade, VI, 145).
Per me, che di questi illustri precedenti letterari nulla allora sapevo, era un incubo perché avevo la disgrazia di non possedere un bel cognome tosco-emiliano, bensì un cognome veneto, cosa di cui, all’epoca, provavo grande vergogna.
Allora, tentando di rimediare, rispondevo: “i son de la Ca’ Nóvva”.
E, nemmeno in questo caso, mi andava sempre bene perché, se mi trovavo nel secondo quartiere, avevo ancora qualche possibilità che sapessero dov’era casa mia, ma nel quarto o nel quinto quasi tutti ignoravano dove si trovasse la Casa Nova, nemmeno quando specificavo: “là in mezzo tra Casa Boni e Casa Evangelisti”.
Nel terzo, invece, respiravo perché mia nonna paterna portava un cognome colà molto noto: Forlai.
A Casa Forlai, entrai molto presto in confidenza con la Divina, e scommetto che tutti i lettori del “San Michele” l’hanno conosciuta e che tutti sono entrati, almeno una volta, nella sua storica bottega.
Ebbene, la Divina sosteneva che lei e suo marito Aurelio eran miei lontani parenti e, ogni volta che la rivedevo, m’accoglieva scotendo la testa ed esclamava: “Accidenta a Zanino! Ch’ha fatto la su ca’ in d’la buga!”.
Ma chi era Zanino? E perché andò a costruire la sua casa verso il fondo della valle?
Ecco, lo potete ammirare nella foto, che probabilmente è del 1899 o del 1900. Data che si può dedurre osservando la bimba che sta alla sua destra e che gli poggia la manina sulla spalla. Si tratta della sua ultimogenita: Cesira, nata nel 1896. Lui è Giovanni Forlai, dal cui diminutivo, Giovannino, si ha Zanino.
Lui è l’avo per eccellenza: bisnonno mio e di tutti quelli della Casa Nova che son della mia stessa generazione.
Attualmente i discendenti di Zanino, che sono tutti miei cugini di vari gradi, sono sparsi in vari angoli della penisola: Bologna, Padova, Bracciano, Teramo, Parma, Piacenza, Castel di Casio e ve ne sono anche in Lombardia. Pochi tra questi sono rimasti proprietari di un’ala della Casa Nova e vi si recano specie nella bella stagione. Gli altri, quelli non posseggono là più nemmeno una stanza, non vi vengono se non di rado o niente del tutto.
Alla Casa Nova – parlo di quelli hanno ancora casa là – siamo tutti parenti o parenti d’acquisto, tenendo conto anche delle mogli o dei mariti dei miei cugini. E l’augurio di tutti è che le case di questa borgata restino tra noi o, al massimo, se proprio qualcuno ne venderà una, che la prenda qualche amico di noi parenti, che tanto siamo affezionati alla nostra “magione avita”.
Il buffo è che, siccome i discendenti di Zanino, si son sempre sposati “in esportazione”, la Casa Nova, in un certo senso, è “poliglotta”: si parlano contemporaneamente più dialetti; si ode l’accento bolognese, ma anche quello romanesco-laziale e quello veneto; tentiamo di parlare pure un poco il boscaiolo, per tenerlo ancora in vita. Quando poi gli uni imitano la cadenza e i modi dire degli altri, c’è da farsi delle matte risate. Ma, credetemi, questa piccola babele non è solo comica, ma ci apre anche la mente.
Torniamo, ora, indietro e osserviamo Zanino (nella foto): un bell’uomo, imponente, doveva essere circa sulla cinquantina: un’età in cui, all’epoca, s’era considerati già vecchi. Inoltre, lui aveva una bella statura, ben superiore alla media dell’epoca, i capelli ancora scuri, naturalmente elegante, pur nel suo vissuto vestito alla cacciatora, stringe le dita l’immancabile mezzo toscano.
Ma perché Zanino aveva lasciato Casa Forlai? Era reticente nel raccontarlo anche alle sue figlie: le mie prozie, che conobbi quasi tutte. Si sapeva vagamente che aveva litigato con i suoi fratelli per la divisione dei terreni paterni, lassù nel terzo e, con quel temperamento che certi suoi discendenti sentono ancora nel proprio DNA, piuttosto che continuare a farsi del sangue cattivo, aveva preferito rinunciare ad ogni pretesa, scegliendo di vivere altrove.
Fu un distacco traumatico, perché ai suoi figli non disse nemmeno il nome dei loro zii, con cui aveva interrotto per sempre ogni rapporto.
Solo negli anni ’90 la Divina, sapendomi curiosa di quest’antica storia di famiglia, mi mise in contatto con un suo fratellastro, oramai decrepito: Sirio, che mi parlò di mio bisnonno. Mi raccontò che, in quel ramo della famiglia Forlai, tutti da sempre sapevano leggere e scrivere: cosa non scontata. Sirio ipotizzava che quei Forlai avessero imparato a scrivere dai vari parroci della chiesa dei Boschi. Mi riferiva inoltre che, a loro volta, i miei avi insegnavano a leggere e scrivere anche ad altri bimbi che frequentavano la loro casa. Mio padre (Mario Tasinato) ricordava che suo nonno Zanino leggeva il Guerrin Meschino e che amava i poemi cavallereschi, infatti, un cugino di mio padre, Giovannino Forlai (figlio di Giacomo, figlio di Zanino) possedeva un’edizione settecentesca dell’Orlando Furioso.
Sirio mi raccontò poi che Zanino, una volta ch’ebbe rinunciato ai terreni che gli sarebbero spettati, “ch’arivav’ne in fin’al Poggio”, lui “ch’era tanto un bell’ommo, si sposò una ereditaria”. Sì, proprio questo termine usò Sirio. La storia di questo matrimonio già la conoscevo, ma raccontata in boscaiolo, prendeva un tono molto più gustoso.
Bene, “l’ereditaria” in questione era una ragazza di Casa Evangelisti: Maria Boni, che possedeva dei terreni e, in uno di questi, Zanino costruì la Casa Nova. Scelse questo nome perché non poteva certo chiamarla: “Casa Forlai bis”, ma anche – è una mia interpretazione – per segnare un tratto di discontinuità netto con la sua vita precedente: per rifondare ex-novo la sua esistenza, tagliando col passato.
All’epoca, la mulattiera passava sotto la facciata sud dell’attuale casa, che era, perciò, la facciata principale, confinante con l’aia, dove sorse il primo nucleo della Casa Nova, e dove fu scattata la foto di Zanino con la piccola Cesira. Nel 1933 fu costruita la “strada barocciable” – come la definiva mia prozia Cesira – che passa al di sopra della facciata nord, situando, da allora, la Casa Nova sottostrada. Lo si vede dalla seconda foto “di copertina”, che è scattata, appunto, dalla strada e che inquadra il tetto del nucleo originario della Casa Nova.
Il primo figlio dei miei bisnonni, Giacomo nacque nel 1883 (morì nel 1964), sicché, desumo che la Casa Nova fu costruita dal 1880 circa in poi. Successivamente, vennero edificate le altre costruzioni: prima un troncone di lato alla casa originaria, poi, nel 1901, la casa di Costante (cognato di Zanino) che forma un angolo retto con le parti più antiche della casa e, via via, altri ampliamenti, dagli anni ’40 fino agli ultimi anni del secolo scorso.
Ma torniamo alla progenie originaria di Zanino. Dopo Giacomo, due gemelli morirono in fasce, poi nacque mia nonna Anita (1887-1977), poi Domenica (Menichina, 1890-1952), Costanza (1892-1969), Pietro (1894-1980) e infine Cesira (1896-1985).
Ma torniamo a Zanino (morto nel 1936), che era un valente muratore: una vera autorità in fatto di muri di pietra. Leggendario fu un diverbio che lui ebbe con un ingegnere che gli contestava la posa d’una pietra su un muro di lato all’attuale strada che va a Casa Boni (là dove parte il vecchio sentiero per Casa Zacchi): “Ingeniere, quel sasso rimarrà là anche doppo che i nostri nevodi saran bell’e morti”. Per la cronaca, oggi quel sasso è ancora là.
Zanino insegnò il mestiere a Giacomo che divenne anche lui un bravo capomastro. Mi sembra ancora di vederlo, quando la sera tornava dal lavoro, bello e alto come suo padre, passo elegante con la giacca dietro le spalle, appesa ad un dito. Ricordo che mia madre diceva: “El pare un divo del cinema, el someja a Gary Cooper”.
Ricordo con nostalgia anche mio prozio Pietro (padre di Luciano, oltre che di Fanny e Marisa), che era sempre allegro e canterino, capace d’improvvisare lì per lì stornelli che mi facevano tanto ridere da bambina, tipo: “S’avete un ricciolino fatt’a molla\e dentro un pidocchino che ci balla (bis)\sbagliate se stimate d’esser bella”.
Io allora non lo sapevo, ma si trattava di endecasillabi perfetti che a lui, e così pure chi sapeva stornellare, venivano in scioltezza.
Ma la fonte principale di tutte le storie del passato era mia nonna Anita, che durante la mia fanciullezza venne alla Casa Nova due sole volte e, presa dai ricordi, mi raccontò cose che ai suoi figli o aveva solo accennato o aveva taciuto del tutto.
Zanino era rimasto in contatto soltanto con una sorella, che, dopo sposata, viveva a Pistoia. M’immagino, attraverso i racconti di mia nonna, come Pistoia fosse allora percepita dalla gente di quassù: una sorta di Ville Lumière. Zanino a Pistoia ci andava assai volentieri, ma sua moglie, gelosa d’un marito così affascinante, pretendeva che lui si portasse sempre dietro mia nonna, ancora bambina. Le raccomandazioni che, in separata sede, le facevano entrambi i genitori erano, da parte della madre, di non lasciar mai solo il babbo e, da parte di Zanino, di non raccontar mai nulla alla mamma, sennò non l’avrebbe più portata in città. Vi lascio immaginare a chi dei due mia nonna desse più retta. Tuttavia, non certo per obbedire alla madre, ma perché era curiosa, la piccola Anita, stava sempre al fianco di suo padre.
Così, mia nonna, con sua grande gioia, accompagnava suo babbo persino nei café chantant. Era la Belle Epoque e questi locali erano aperti anche di pomeriggio. La nonna mi raccontava che le sciantose, tutte pizzi, gambe e spalle non tanto coperte, si sedevano sulle ginocchia dei clienti, dove continuavano a cantare canzoni che la nonna memorizzava avidamente e che insegnò a me, quando avevo la sua stessa età.
Immaginate, in pieni anni ’50, lo scandalo che provocai in mia madre, quando mi misi a cantare a gola spiegata: “Quando l’amante mia se n’andò via, mi venne un colpo al cor che più non fiatai\le diedi la roba sua, mi diede la mia\ siccom’amata non l’avessi mai etc.”. Oppure: “In quella barchettiella ci vengo se tu voi\i baci miei coi tuoi, li potremo accompagnar etc.”.
Interrogata da chi avessi imparato simili sconcezze, rispondevo bellamente: “Dalla nonna Anita!”. E mia madre, che mal sopportava sua suocera, faceva scenate a mio padre – le uniche che mai le vidi fare a suo marito – e ingiungeva perentoria: “Dighe a to mama che ghea mo(e)a de cantar sti sporchessi a la putea!”. Mio padre, molto meno moralista e che per sua madre stravedeva, si limitava a dirle con dolcezza: “Mama, ricordate che la putea ea xe ‘ncora picenina!”. Ovviamente, queste discussioni avvenivano a bassa voce e dietro alla porta chiusa d’una stanza, da cui ero stata estromessa, ma io non mi perdevo lo stesso una parola.
Al che, temendo che la nonna non mi raccontasse più nulla, l’assicuravo che sarei stata zitta e che, d’ora in avanti, avrei cantato le sue canzoni solo per conto mio.
Allora la nonna Anita, rincuorata e assai desiderosa di rievocare i tempi suoi, mi pigliava in disparte e dava la stura ai suoi ricordi.
Mia nonna, tra l’altro, mi raccontava poi di come, ogni anno, giungesse alla Casa Nova “dalla Toscana” un bravo ciabattino, che confezionava robuste scarpe a tutta la famiglia. Siccome, per ultimare questo suo lavoro, c’impiegava qualche giorno, rimaneva ospite di mio bisnonno Zanino. La cosa che più piaceva a mia nonna è che costui cantava ininterrottamente mentre era al lavoro e, ogni anno, aveva un repertorio nuovo di romanze, di bruscelli e di rispetti (canzoni in cui un uomo e una donna si rispondono) di argomento antico, tipo La Pia de Tolomei, o altre storie ambientate in tempi ben più recenti. Chiaramente, mia nonna imparava ogni cosa a memoria. A otto anni cantavo con lei tutto il suo repertorio, a undici (che fu la seconda e ultima volta che mia nonna venne alla Casa Nova), cominciai a comprendere che si trattava d’un patrimonio artistico inestimabile e mi preparai con carta e penna pronta a trascriverne le parole (le arie le ricordo ancora), ma – ahimè! – a mia nonna cominciava già a venir meno la memoria, non in generale ma solo per questi testi nella loro interezza; ve n’erano certi che, se eseguiti dall’inizio alla fine, potevano durare anche più di un’ora. Ebbene, non averne potuto conservare che qualche piccolo brano, rimane uno dei rimpianti più cocenti di tutta la mia vita!
La nonna era la più bella delle sorelle, ma anche Menichina era graziosa. Anita, però, sapeva vestirsi con gusto, specie perché, nel frattempo, aveva imparato a far la sarta. Si confezionava, ad esempio, camicie con ampi jabot, consumando senza risparmio gran parte della tela a disposizione per tutte le fanciulle di famiglia, facendo molto arrabbiare le sorelle, per le quali lei cuciva camicie con quello ch’era rimasto, ossia con volant striminziti.
Naturalmente, Anita era corteggiatissima e aveva uno stuolo di “filarini”, parola, che a me, bambina veneta, suonava attraente e misteriosa perché non sapevo bene se significasse solo ammiratori o anche fidanzati. A mia richiesta di precisazioni in proposito, la nonna fece capire che, nel suo caso, dovevo pensare più che altro alla prima possibilità.
Poi, all’improvviso, assumeva un’espressione cupa e mi raccomandava con veemenza: “Te agli omni digli sempre d’no!”. Io, facendo l’innocentina, sfoderavo la mia aria più candida e le chiedevo: “Ma d’no a cosa, nonna?”. Al che lei, ricordandosi d’un tratto della mia tenera età e delle raccomandazioni di suo figlio, diventava più vaga e mi diceva: “Te principia a dirgli d’no, ché doppo a tal spiéggo”.
Quel “doppo” purtroppo non venne mai, perché la totale confidenza, ch’era magicamente sorta tra noi alla Casa Nova, in città (a Padova), svanì completamente e là lei mantenne con me sempre un grande riserbo.
Però, in quelle due memorabili estati che passammo assieme, per fortuna, feci a tempo a sapere tante altre cose.
Una storia, in particolare, ancora la faceva star male, e sì ch’era passato almeno mezzo secolo. Me la raccontò, non prima d’essersi prodotta in altre raccomandazioni a mia futura memoria, il cui succo era riassunto in questo monito: “Bada, ché gli omni son tutti mascalzoni!”. E io ad annuire con vigore, sperando che lei si decidesse finalmente a raccontarmi perché.
Insomma, a Molino del Pallone capitò un giovane Capostazione di prima nomina. Era di Firenze, bello, biondo e con il baffo guascone. Nemmeno a dirlo, tutte le ragazze delle valle ci misero subito gli occhi sopra, ma lui non le guardò nemmeno e s’innamorò di Anita.
Del resto, nessuna poteva competere non tanto con la sua bellezza – non voglio pensare che non ci fosse nessun’altra fanciulla carina – ma piuttosto con l’aria cittadina di Anita, con la sua eleganza e con la sua parlata, visto che, fin da bambina, lei aveva imparato ad esprimersi, all’occorrenza, in perfetto toscano.
E il giovinotto faceva sul serio, tanto ch’aveva scritto a sua madre a Firenze, invitandola a recarsi a Molino per venire a conoscere una ragazza che lui era intenzionato a sposare. Mostrò poi la lettera di risposta della madre a mia nonna che, nel frattempo, s’era innamorata perdutamente di lui.
E qui scoppiò il dramma. Perché la gioventù della valle era pronta a tutto pur di mettere i bastoni tra le ruote a questo matrimonio. Partì, così, un micidiale contrattacco concentrico: le fanciulle, invidiosissime d’esser state schifate dal Fiorentino, insinuarono a quest’ultimo che mia nonna aveva avuto troppi morosi prima di lui, soprattutto inventando. I ragazzi, che si dividevano tra i pochissimi ex di mia nonna e tra i ben più numerosi respinti, organizzarono violente sassaiole sopra-strada, ogni volta che il Capostazione si moveva da Molino per andare incontro ad Anita.
Alla fine, costui – che, associandomi a mia nonna, non esito a definire un grandissimo vigliacco – invece di sposarla alla faccia delle malelingue e di tali riti tribali e intimidatori, le diede un appuntamento al Grotto dei Rondoni e la lasciò dicendole che era: “troppo chiacchierata”.
Vi lascio immaginare il grande dolore e la grande delusione di mia nonna… e adesso vi spiegate tutti gli ammonimenti che lei mi dava.
Dopo di che, il vile Capostazione chiese il trasferimento da Molino, e l’ottenne, mentre mia nonna cadde nella disperazione.
Però, nelle vene di Anita scorreva lo stesso sangue di Zanino, sicché era pronta a dare un taglio netto con quanti le avevano fatto un torto. Solo che a Zanino era bastato abbandonare Casa Forlai e fondare una nuova borgata (la Casa Nova), non molto lontano di là, per rifarsi una vita, mentre mia nonna, ben più drastica, cominciò a detestare la valle tutta e i suoi abitanti in blocco, dove, ai suoi occhi, abbondavano gli invidiosi e i malparlieri. Non offendetevi, cari lettori, ma mettetevi nei panni d’una fanciulla vittima d’una perfida congiura.
Cominciò a recarsi spesso a Porretta, dove talora giocava al lotto. L’accompagnava sempre suo fratello minore, Pietro (futuro eroe della Grande Guerra), che era ancora un ragazzetto e che poi mi raccontò che ci andavano a piedi e che lui faceva una fatica tremenda, al ritorno, perché era carico di monete che pesavano parecchio. Giacché, come recita un classico proverbio, mia nonna era sfortunata in amore e fortunata al gioco.
Anita non passò inosservata nemmeno a Porretta, dove molte facoltose famiglie venivano a villeggiare e a curarsi alle Terme. In particolare, la notò un conte padovano, il quale, anche lui affascinato dalla parlata e dai modi di mia nonna, le propose d’andare a lavorare a casa sua, in modo da insegnare ad esprimersi con proprietà alle sue figliole, nobili ma pur sempre con una vistosa cadenza veneta. Insomma, a casa di questo conte, che si rivelò una persona molto seria e affidabile, mia nonna non andò a “fare la serva” quanto, piuttosto, a diventare una sorta di dama di compagnia per quelle aristocratiche signorine.
Restava da convincere Zanino a separarsi dall’amata figliola, che voleva partire da sola per un mondo totalmente sconosciuto, quale allora era il Veneto per un tosco-emiliano.
Voi mi obietterete che anche moltissimi abitanti della valle, all’inizio del ‘900 e anche dopo, si trovarono ad emigrare. Beh, non è esattamente la stessa cosa: tutti quelli che andarono a lavorare in Francia o in Belgio s’appoggiavano ad una piccola comunità di Italiani, spesso compaesani, che già risiedevano là e che erano pronti a sostenerli e ad aiutarli, fino a quando si fossero ambientati all’estero.
Mia nonna, invece, era una fanciulla sola e senza punti di riferimento di sorta a Padova, ma era coraggiosa e molto determinata e, alla fine, Zanino, pur a malincuore, cedette alle sue insistenze e sospirando le diede il suo benestare, uscendosene in una frase storica: “Vai, vai! Tutti i forni danne pane!”.
E così mia nonna si stabilì a Padova e là sposò un giovane pittore di Abano Terme: Giovanni Tasinato, titolare di un’impresa che decorava e affrescava le ville nobiliari.
Adesso sapete perché la mia famiglia ha un cognome veneto e perché i Tasinato talora si esprimono in tale spassoso dialetto.