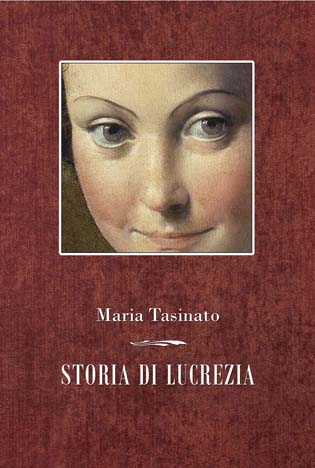EDIPO TRIUMPHANS
Per mio padre
A miei nipoti
Cecilia e Edoardo
Premessa
Nell’estate 2022 cadevano due anniversari: erano trent’anni esatti da quando era morto mio padre (Mario Tasinato, 1919-1992) e contemporaneamente, essendo nata nel 1950, mi avviavo verso l’età in cui lui era venuto a mancare: poco meno di 73 anni.
Insomma, una boa gigantesca che non potevo ignorare e che ero costretta, in qualche modo, a doppiare.
Per decidermi a scrivere dovetti superare non poche resistenze e affrontare grandi difficoltà.
Ne indico solo un paio.
Non volevo assolutamente fare un racconto intimistico, cosa che reputo dolciastra e che, inoltre, avrebbe stonato col carattere anti-sentimentale del mio genitore.
Giudicherete voi se ci sono riuscita.
Un grande scoglio era, inoltre, rappresentato dalla lingua perché mio padre, che pure era un uomo colto, non si esprimeva quasi mai in italiano, bensì in dialetto veneto. Sicché la teatrale potenza delle sue battute, spesso assai divertenti, sarebbe andata quasi interamente perduta se mi fossi limitata a tradurle. Risolsi, allora, di traslitterare le sue uscite in vernacolo e offrire una neutra resa italiana, tra parentesi, per i non-veneti.
Veniamo al titolo.
Salta agli occhi una polemica nei confronti della psicanalisi, che si affretterebbe a vedermi come un caso clinico. Ebbene, non mi importa nulla che mi si possa giudicare come un soggetto che non ha “risolto”, nemmeno in tarda età, il proprio “complesso di Edipo”, per dirla con Freud, o per dirla con Jung, il proprio “complesso di Elettra”.
Se anche così fosse, la cosa non mi tocca.
Perché quello che non mi convincerà mai è appunto quel “risolvere”, quel “superare”, che è sotteso ad ogni analisi.
“Superare” … e per andare dove? Verso una vita affettiva o, peggio che peggio, di coppia, “normale”?
No, grazie!
Perciò, dovendo mettere su un piatto della bilancia il non essere stata molto serena nonché “istituzionale” nella mia vita amorosa e collocare sull’altro piatto tutto quello che mi ha dato mio padre, beh, io guardo solo quello che sta su questo secondo piatto. L’unica cosa che conti davvero per me.
Infine, almeno dalla seconda metà del secolo scorso in poi, la psicanalisi è anti-edipica, se non post-edipica.
A tutte queste dispute io rispondo con una risata e insieme con una provocazione:
EDIPO TRIUMPHANS!
Buona lettura!
1. Mio padre e la morte.
Voglio cominciare da un episodio che può suonare molto sconcertante ma che è rivelatore al sommo grado.
Mio padre era dotato di una salute di ferro unita ad una prestanza fuori dal comune, sicché, a quasi settant’anni, era ancora intatto, sia nella straordinaria energia fisica, sia nella lucidità mentale.
Insomma, sembrava indelebile e completamente inattaccabile da ogni tipo di decadenza.
Non si sarebbe mai detto che di lì a poco un micidiale cancro lo avrebbe aggredito all’improvviso e portato alla tomba in poco più di un anno.
Eppure, giunta quasi ai miei quarant’anni – avevamo trentun anni di differenza – cominciai a temere che prima o poi mio padre si ammalasse, potesse invecchiare e infine morire.
Un timore del tutto astratto, come ho appena detto, e immotivato.
Proruppi, allora, in una frase accorata e traboccante di amore filiale:
– Papà, prego sempre di morire prima di te.
(Non sono credente, ma talora mi comporto come una devota o, meglio, lo divento temporaneamente. Ossia, mi accade di pregare qualche raro santo che mi è simpatico, quando qualcuno che mi è caro sta male. In quel caso, si era trattato di una prece preventiva).
Mio padre detestava le scene drammatiche o, in generale, piene di pathos sentimentale ed era portato a farle cessare immediatamente grazie ad una battuta corrosiva.
Che arrivò inesorabile.
Mi guardò beffardo e rispose lapidario:
– Ghé stago! (“Ci sto!”), il che significava che era perfettamente d’accordo a morire dopo di me.
Mi finsi scandalizzata, obiettandogli che il suo era un amore paterno che lasciava a desiderare.
Ma già intuivo che era pronta una seconda stilettata:
– Ti te sì più zóvane de mi e saría naturae che morisse prima mi, ma, se te mori prima ti, vol dire che go ‘na bea possibiità de vivare ‘n altro bel fià! (“Tu sei più giovane di me e sarebbe naturale che morissi prima io, ma se muori prima tu, significa che ho una bella possibilità di vivere piuttosto a lungo”).
Scoppiammo a ridere tutti e due.
In realtà quello della morte era un tema molto spinoso per mio padre, che non faceva mistero di detestarla (Ea morte xé ‘na gran bruta roba! “La morte è una faccenda molto brutta”) e rifuggiva apertamente dai discorsi che anche solo la nominassero. Non andava quasi mai ai funerali e sbeffeggiava una sua sorella, che, invece, non se ne perdeva uno: Ciò, robe da mati, la Ada, la ga el police nèro! (“Pazzesco! Ada ha il pollice nero!”).
Non aveva il culto dei morti e si teneva alla larga dai camposanti. Una volta giunse a dirmi, nominando in via eccezionale, la Nemica:
Co’ sarò morto, no’ sta’ vegnérme trovare: non me interessa un bao! (“Quando sarò morto, non venire sulla mia tomba: non è affatto una cosa che mi interessi!”).
Al suo orrore di dover morire, che fu in lui fortissimo prima di ammalarsi, si accompagnava un’enorme paura fisica, che sconfinava nel ridicolo.
Era la cosa che meno sopportavo in lui.
Non volle mai prendere un aereo e, quando era in macchina e non era lui a guidare, cosa che succedeva nell’ultima parte della sua vita a causa di una cateratta problematica, diventava un vero assillo per il povero guidatore.
Ricordo la pazienza infinita di mio fratello, che durante tutto un viaggio, si sorbiva senza fare una piega una litania ininterrotta di: Piàn, Nino! Va piàn! Te go dito de ‘ndar piàn, Nino! Se ghe xé scrito 20 km a l’ ora, ghe sarà el so parché! Piàn, Nino! Va piàn! (“Piano, Giovannino! Va piano! Ti ho detto di andare piano, Giovannino. Se c’è scritto 20 km all’ora, ci sarà una ragione. Piano, Giovannino! Va piano!”).
Mio fratello rideva ma io ero furibonda e non era raro che scendessi al primo paese e proseguissi in treno.
Tuttavia, quando si ammalò, sopportò stoicamente i tanti dolori lancinanti senza mai lamentarsi, non s’illuse mai di potersela cavare e fu sereno ed imperturbabile fino all’ultimo.
Il tutto, però, senza mai nominare la fine ormai prossima davanti ai più stretti familiari.
Venimmo a sapere, tempo dopo la sua dipartita, che aveva preso commiato telefonicamente con alcuni suoi cugini, che abitavano in città lontane e che vedeva raramente. A questi disse chiaro e tondo, e senza nessuna emozione apparente, che aveva i giorni contati. Essendo lui il ritratto della salute, non gli vollero credere.
2. Mio padre e la famiglia.
Mio padre amava molto mia madre, con cui era sempre gentilissimo, e siccome, fin da piccina, io non riuscivo proprio ad andare d’accordo con lei, mi raccomandava sempre (lo fece anche sul letto di morte):
Porta pasienza co’ to mama! Eo so che ea xé dura, ma fa(e)o par mi! (“Porta pazienza con tua mamma! Lo so che è dura, ma fallo per me!”).
Questo era l’unico ricatto cui mio padre, in casi estremi, ricorreva: il più pesante.
Ricordo che una volta, ero molto piccola, esasperata per i continui rimproveri materni, chiesi a mio padre:
– Papà, ma perché, tra tutte le donne che c’erano, hai sposato proprio lei?
Mi guardò con la sua aria da finto ingenuo e poi sparò:
Parché ea xé sta ea prima che ea me ga dito de sì! (“Perché è stata la prima che mi ha detto di sì!”).
Informazione fin troppo preziosa per una bambinetta continuamente vessata dalla genitrice!
Insomma, non appena mia madre, per l’ennesima volta, mi sgridò per futili motivi, non mi parve vero di dirle, con immensa soddisfazione, che il papà l’aveva sposata solo per un certo motivo.
Successe un putiferio e io gongolavo assistendo ad uno dei loro rarissimi litigi.
Confesso che sognavo che i miei genitori si lasciassero e che mio padre poi vivesse solo con me.
Delirio edipico! Beh, sì! E allora?!
La cosa singolare fu che, a mia madre, che lo rimproverava per avermi detto quella che, ai suoi occhi, era un’imperdonabile bestialità, lui, imperterrito, replicò:
Ana, xé la verità! (“Anna, è vero!”).
Al che, gli urli di mia madre andarono alle stelle e, in seguito, lei tenne il muso a suo marito per una decina di giorni almeno.
Tenere il muso era una specialità di mia madre, ma non certo di mio padre, che poteva dire, ma anche sentirsi dire, le cose più velenose senza poi serbare alcun rancore.
Appena più grandina, interrogai la sorella preferita di mio padre (zia Gemma) circa le disavventure sentimentali del mio genitore, anteriori al suo matrimonio.
Venni così a sapere che lui aveva fatto una dichiarazione assai romantica ad una compagna di scuola di mia zia e che era stato respinto.
Il tutto era accaduto prima della guerra, dunque, quando mio padre aveva circa vent’anni, o anche meno. Di altre sue love stories (incombuste e non) mia zia non sapeva nient’altro, temo, perché quel rifiuto deve essergli bruciato tantissimo. E deve averlo scoraggiato parecchio.
In seguito, mio padre partì per la guerra, conobbe mia madre solo dopo che tornò dalla prigionia e si fidanzò subito con lei nel 1946.
Da bambina impicciona e curiosissima quale ero, frugai un giorno in un cassetto del comò della camera da letto dei genitori e trovai uno strano cuscino tondo, ricamato a mezzo punto. Lo palpai e, sentendo che l’imbottitura era rigida ed irregolare, ne scucii una parte e vi scoprii le lettere d’amore che ogni sera mio padre aveva scritto a mia madre durante tutto il periodo del biennale fidanzamento.
Erano lettere molto poetiche, ancorché caste.
Allora le Poste funzionavano egregiamente e mio padre, che andava a trovare la promessa sposa ogni sera a casa dei genitori di lei, appena lasciatala, subito le scriveva una missiva che imbucava la mattina dopo e che mia madre riceva al massimo ad ora di pranzo.
Queste lettere, che lessi avidamente, rivelavano una grande passione. Eppure, mio padre, pur di non sconfessare la sua precedente battuta, che faceva sembrare mia madre un ripiego, un faute de mieux, fu pronto a ribadire, appunto: Ana, xé la verità!
In seguito, ero ancora piuttosto piccola, mio padre mi prese da parte e proclamò:
Ciò, pico(e)a – si rivolse a me con tale appellativo, in qualsiasi mia età – no’ sta a maridarte! Scóltame mi! La famegia xé ‘na gran rotura de scatoe! (“Stammi a sentire, piccola, non devi sposarti: la famiglia è una gran rottura di scatole!”).
Tali parole erano un gran balsamo per me perché, fin dalla mia più tenera infanzia, mia madre sentenziava minacciosa che avevo un caratteraccio e che, perciò, sarei sicuramente rimasta zitella. E il nubilato, per una donna della sua generazione, equivaleva al fallimento più totale.
Vi erano altre frasi che demolivano senza appello la retorica della famiglia, ricordo che non aveva nessun problema ad affermare:
No’ posso vedare quei che i dize: “Go fato un saco de sacrifissi par la famegia!”. Che ebeti! Mi sacrifissi par voialtri no’ ghe ne fasso! (“Non posso vedere quelli che dicono: ‘Ho fatto un sacco di sacrifici per la famiglia!’. Che stupidi! Io sacrifici per voi non ne faccio!”).
(Pensate che una simile uscita mi ferisse? Nient’affatto! Lo ammiravo ancora di più quando diceva cose del genere).
A ben guardare, mio padre in famiglia ci stette relativamente poco, perché lavorava spesso in altre città.
Ad esempio, dal 1957 al 1961 visse ad Udine, dove noi lo raggiungemmo un anno dopo (nel 1958).
Fu a Padova dal 1961 al 1965 ma, negli ultimi due anni, lavorava a Mestre.
Nel 1966, per un anno, si trasferì, senza che la famiglia lo seguisse, a Gorizia e, in quel periodo, tornava a casa, per un breve fine settimana, solo ogni quindici giorni (A Gorissia, stavo propio benón! “A Gorizia, stavo benissimo!”), mi confessò in seguito.
Dopo Gorizia, fu la volta di lunghi anni a Rovigo. E, anche se mio padre tornava a casa per cena, si alzava ogni mattina alle cinque, sicché lo si intravedeva per un paio di ore al massimo, perché si doveva coricare più presto di quello che lui avrebbe voluto.
Mio padre non sopportava né Rovigo, né i Rovigoti e succedeva che, a mo’ di risarcimento, almeno una volta alla settimana, lui non si presentasse nemmeno per cena.
In quei casi, telefonava a mia madre accampando un alibi di ferro:
Ciò, Ana, me so indormensà e me so svejà ch’el treno gera zà rivà a Venéssia: no’ sté ‘spetarme a to(e)a (“Anna, mi sono addormentato e mi sono svegliato quando il treno era già arrivato a Venezia: non aspettatemi per mangiare con voi”).
Nessuno gli credeva e io me lo immaginavo scorrazzare libero e beato per una città che lui amava moltissimo.
Va detto che mia madre, tanto era severa con la sottoscritta, tanto era indulgente col marito e non gli faceva se non rari e blandi rimproveri per la sua latitanza.
Infine, mio padre lavorò a Padova solo negli ultimissimi anni prima della pensione.
Insomma, il tempo che passai con lui non fu, in definitiva, molto: i fine giornata ad Udine e, ogni estate, tutto il mese di agosto che lui trascorreva immancabilmente con la famiglia e con vari suoi parenti nella casa avita sugli Appennini tosco-emiliani. Sua madre era, infatti, originaria di quelle contrade, cui lui era rimasto legatissimo.
Tuttavia, non fu la quantità bensì la qualità del tempo, che trascorsi con mio babbo, ad imprimere in me un’impronta indelebile.
Ma su questo ritornerò con calma.
3. Mio padre e il lavoro.
Ma che lavoro faceva mio padre?
Per un bel po’ continuai a non sapere niente di preciso, fin quasi alla fine delle mie elementari.
In realtà, non ero particolarmente curiosa di saperlo.
Quando abitavo ad Udine, mi era bastato visitare, una volta, il suo ampio ufficio, con finestre molto grandi che si affacciavano sulla monumentale Piazza della Libertà, dalla parte dove cominciava la strada per il Castello.
Quella piazza, piena di grosse statue, e quel selciato in salita mi piacevano molto, sicché m’accontentavo di sapere che mio padre là faceva il capoufficio.
Ma non avevo fatto i conti con le mie compagne di classe che, essendo io l’unica bambina non friulana, quindi, una straniera, mi tempestavano di domande sulla mia famiglia.
Allora, imploravo mio padre di spiegarmi bene che mestiere facesse, così da poter finalmente rispondere a quelle piccole comari.
Niente da fare! Per mesi e mesi, lui mi rispondeva infastidito:
Eàssa stare, pico(e)a! El me lavoro? Tristésse! (“Smettila, piccola! Il mio lavoro? Niente di divertente!”).
Alla fine lui fu costretto a spiegarmi che lavorava in un ente parastatale (mi imparai bene la dicitura, che per me non significava molto), che si occupava di motorizzazione agricola.
L’unica cosa che mi aveva detto è che faceva spesso visite mirate in varie case coloniche nell’interland friulano.
E se c’era qualcuno che non subiva il fascino della campagna era lui, probabilmente perché era nato ad Abano Terme.
Nonostante, nei primi anni, fosse l’unico laureato in tutta Italia in quell’ente e, da semplice impiegato, fosse diventato presto capufficio, credo che avesse lo stesso uno stipendio piuttosto misero: molto inferiore a quello degli statali.
Ovviamente, le mie compagne di scuola pretendevano che dichiarassi loro la cifra esatta, pretesa che pure io stimavo assurda e indelicata. Quanto all’ammontare del suo stipendio, mio padre lo definiva semplicemente: ‘na miseria (“una miseria”). In effetti, il tenore di vita in casa mia era molto modesto.
Seppi solo in seguito che aveva cominciato quel lavoro per caso, per mantenersi all’università – era rimasto orfano già negli anni del liceo. Appena tornato dalla guerra, per inerzia, non lo aveva più cambiato.
Si era laureato in Lettere piuttosto frettolosamente e si intuiva che gli sarebbe piaciuto insegnare.
Quando già facevo le medie, aveva tardivamente tentato un concorso per diventare professore, ma non lo aveva superato. E sicuramente non perché non fosse preparato in Storia e in Letteratura Italiana, materie che amava molto e in cui era assai ferrato, ma perché la commissione giudicante aborriva da qualsiasi interpretazione originale. Si era scoraggiato e così era rimasto in quell’ente, che lui definiva inutile, fino alla pensione, senza mai adoperarsi per avanzare di grado.
Riguardo al lavoro in generale, non aveva nessuna ambizione e non nascondeva quello che ne pensava:
El lavoro xé ‘na maedissión! El lavoro xé ‘na danassión biblica! (“Il lavoro è una maledizione! Il lavoro è una dannazione biblica!”).
E, per essere ancora più chiaro, rincarava:
Un omo che se rispéta nol lavora, ma el vive de rendita! (“Un uomo degno di rispetto non lavora, ma vive di rendita”).
E qui va detto che mio padre non proveniva certo da una famiglia nobile decaduta, né tantomeno da una di proprietari terrieri: aveva maturato questo ideale di sovrana nullafacenza del tutto di suo.
Le sue filippiche contro il lavoro toccavano l’apice, quando si lasciava andare ad una considerazione sconsolata circa il fondamento stesso dello stato italiano, così come era stato concepito nel dopoguerra:
Quando go sentío el primo artico(e)o de la Costitussión, ch’el dixe che l’Italia xé ‘na republica democratica fondà sul lavoro, ciò, me xé cascà i brassi! (“Quando ho sentito il primo articolo della Costituzione, che dice che l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, beh mi son cadute le braccia!”).
Se non fosse abbastanza chiaro, mio padre era decisamente antiretorico riguardo a valori che ovunque e ognora venivano esaltati: in primis, la sacralità della famiglia e del lavoro.
Mio padre non era semplicemente anticonformista: era profondamente dissacrante.
4. Mio padre e la Provvidenza.
Mio padre non era ateo quanto piuttosto un credente sui generis. Andava a messa tutte le feste comandate, ma quasi mai con la famiglia. Si confessava e riceveva l’Eucarestia, ma solo una volta all’anno: a Pasqua.
Quando ero già grandicella e cominciai a nutrire una certa avversione per la religione, in cui ero stata educata in maniera ferrea (mia madre era una cattolica intransigente), lo interrogai in proposito. Gli dissi che non capivo perché lui, scettico com’era su quasi tutto, andasse in chiesa, quando mi era chiaro che, sotto sotto, era un agnostico.
Non si scandalizzò, né lo negò ma, con un’alzata di spalle, mi rispose che andare apertamente contro alla religione gli sarebbe costata troppa fatica. E poi temeva le scenate di mia madre, che andavano evitate. Tanto che gran problema era andare a messa e frequentare i Sacramenti lo stretto necessario?
Ora voglio raccontarvi una scenetta emblematica che mostra il piglio polemico di mio padre l’unica volta che emerse chiaramente nei confronti di uno dei capisaldi della religione cattolica.
O, quantomeno, si trattava di un principio cui allora si credeva molto più di adesso, tenuto anche conto che erano generazioni che, a scuola, avevano assunto over-doses di Manzoni.
Dovete sapere che mia madre, donna molto raffinata e bellissima in ogni età, amava moltissimo essere elegante. Non avendo mai lavorato in vita sua, non le era molto chiaro il valore del denaro e, specie per le sue spese personali, aveva le mani bucate. Mio padre le consegnava la quasi totalità del suo modesto stipendio, tenendo per sé solo i soldi per le sigarette, per poter andare al bar e per le trasferte di lavoro.
Non era raro che mia madre facesse debiti con qualche negozio di abbigliamento, debiti che lei poi sanava con rate regolari, ogni mese.
Questo andazzo non garbava troppo a mio padre che però cercava di non insistere su quel tasto. Si limitava a dire ironicamente, ogni volta che scorgeva un capo di vestiario mai visto prima addosso a mia madre:
Ana, questo el xé novo, vèro? (“Anna, è un nuovo acquisto? Non negarlo”).
Mia madre, invece, puntualmente affermava che no, quel vestito ce l’aveva dall’anno prima, dalla fine della stagione, sicché lo aveva potuto mettere pochissimo, insomma, era mio padre che non vi aveva fatto caso.
Al che, lui scuoteva la testa indulgente.
Tuttavia, ci fu una volta che mio padre si seccò e parecchio.
Mia madre aveva trionfalmente fatto ingresso in casa con una pelliccia di rat mousquet. La cosa straordinaria non era tanto la pelliccia in sé, che non era stata acquistata, perché era appartenuta alla madre di mia madre e giaceva da anni dimenticata in un armadio, quanto come era stata sapientemente rimodernata.
Il modello era originalissimo: godé nella parte sotto, con le maniche un po’ bombate, il collo graziosamente arrotondato e grandi bottoni tondi di cuoio. Molto chic nel suo complesso e si vedeva lontano un miglio che questa rimessa in sesto non doveva essere costata poco.
Mio padre, piuttosto basito, chiese a mia madre dove avesse fatto rifare la pelliccia, e lei, con orgoglio e con una certa aria di sfida, disse il nome di una notissima e antica boutique cittadina, che era un faro nel ramo, che notoriamente aveva prezzi proibitivi e che, con tutta probabilità, non vendeva nulla a rate.
Al che, mio padre le chiese piuttosto severamente dove avesse trovato i soldi per una simile spesa astronomica.
Mia madre non voleva rispondere e faceva la misteriosa.
Mio padre suppose dapprima che lei avesse chiesto un prestito:
Stavolta, Ana, tea ghe fata grossa! Dime chi xé stà! Xé sta Gino? (“Questa volta, Anna, hai esagerato. Dimmi chi è stato! – sottointeso a finanziarti – È stato Gino?”). Si trattava del fratello maggiore di mia madre che aveva un tenore di vita ben superiore al nostro.
Mia madre negò, e con soddisfazione.
Allora lui si rivolse a me:
Pico(e)a, te ga domandà schèi a ti? (“Piccola, ha domandato soldi a te?”).
Allora avevo appena cominciato l’università e, per mantenermi agli studi, facevo qualche lavoretto e non era raro che foraggiassi mia madre – nel vano tentativo di ammansirla – per qualche borsa o per qualche cappellino, tuttavia i miei scarsi mezzi non sarebbero mai arrivati fino al rifacimento di una pelliccia.
Risposi che, quella volta, non c’entravo proprio.
Ana, go da savère chi te ga dà i schei! (“Anna, devo sapere chi ti ha dato i soldi!”), insisté mio padre.
Mia madre evasiva dichiarò:
Xé sta la Providensa! (“E stata la Provvidenza!”).
Mio padre si stava proprio arrabbiando e scoppiò:
Cossa? La Providensa?! Ma qua(e)a Providensa?! La Providensa no’ esiste! (“Cosa dici? La Provvidenza?! Macché Providenza! La Provvidenza non esiste!”).
E rivolgendosi direttamente a me:
La Providensa xé ‘na serie de ébeti, tipo mi e ti, che semo qua par pagare i caprissi de to mare! (“La Provvidenza è una serie di stupidi, tipo me e te, che siamo qua a pagare i capricci di tua madre”).
Il fatto che avesse osato dire mare e non mama, espressione da cui lui di solito si asteneva perché ritenuta plebea e, dunque irricevibile, dalla mia genitrice, era indice di quanto lui fosse infuriato.
Mia madre ribatté, sempre con aria di sfida:
Mi go le me risorse segrete! (“Io ho le mie risorse segrete!”).
No, Ana! ‘Desso ti te me disi dove te ghe trovà tuti quei schèi! (“No, Anna, adesso tu mi dici dove hai trovato tutti quei soldi!”).
Al tono di mio padre che, una volta tanto, non ammetteva repliche né altri sotterfugi, mia madre alfine confessò.
Lei, che era molto socievole, frequentava delle amiche con cui ogni giorno andava a messa e poi in un bar vicino al Duomo a bere una tazza di orzo.
Ebbene, a tale gruppetto si era da poco aggiunta una signora già piuttosto anziana, rimasta vedova di recente. Costei conviveva burrascosamente con una sorella nubile, più giovane, che la tiranneggiava e che trovava da ridire quando l’altra, per avere un po’ di pace, si vedeva con le amiche.
Bèe le to amiche! Le xé tute false! Scométo che quando te moriré no’ le vegnarà gnanca al to funerae! (“Belle le tue amiche! Sono tutte ipocrite! Scommetto che quando morirai non verranno nemmeno al tuo funerale!”), insinuava la sorella inacidita .
Per reagire a tali angherie, la vedova aveva convocato in segreto mia madre e l’aveva incaricata di una missione:
Ana, co’ moro, prometime che te farè pareciare ‘na ghirlanda de fiori, bea granda, dove ghe sarà scrito ciaro: LE TUE AMICHE. Sèto che rabia par me sorèa! (“Anna, quando morirò, promettimi che farai approntare una ghirlanda di fiori, bella grande, con una scritta ben visibile: LE TUE AMICHE. Immagina la rabbia di mia sorella!”).
E, a tale scopo, aveva dato in deposito a mia madre una somma cospicua: era quello il fondo segreto cui la “fidata” amica Anna aveva attinto a piene mani!
Questo succoso racconto per me era comico ai massimi livelli, ma mio padre restava serio e minacciò:
Ana, se sciopa la vecia, ricordate che mi, par la corona, schéi no’ te ne dago! (“Anna, se alla vecchia viene un colpo, ricordati che io soldi per la corona non te ne do!”).
Mia madre replicò che l’anziana amica godeva di ottima salute e che lei avrebbe messo da parte nel suo libretto di risparmio, non particolarmente guarnito, una piccola somma ogni mese fino a riformare il fondo iniziale.
Passarono gli anni e ogni tanto mio padre s’informava:
Ana, come sta(e)a ea vécia? Ricordate che, se la more, ti te te rangi: mi no’ te giuto! (“Anna, come sta la vecchia?, Ricordati che, se muore, tu ti arrangi: io non ti aiuto!”).
Ma ormai lo diceva con tono da finto burbero, nascondendo la voglia di ridere.
Finì che mia madre fece a tempo a reintegrare il “prestito ” perché la signora morì molto attempata e poté avere la sua corona trionfale.
Tale spassosa storia de ea peíssa (“storia della pelliccia”), è degna della grande tradizione teatrale veneta e, per me, è “arte” allo stato puro. Se ci ripenso – anche ora che ne sto scrivendo – rido di cuore a distanza di tanto tempo.
Basti dire che, in quel caso, trovavo, e tuttora trovo, persino molto simpatica mia madre…
5. Mio padre e le donne.
Mio padre non era bello in senso classico. Tanto per cominciare non era certo alto: tuttavia, per la sua generazione, il suo metro e settanta era una statura più che accettabile per un uomo. Non così, invece, per i canoni della mia.
Non era snello, ma non aveva la pancia prominente, le spalle erano larghe, le gambe, anche se le esibiva molto di rado, parevano dipinte da Caravaggio – fu lui stesso a suggerirmi questa suggestione: unica sua vanità che, però, era azzeccatissima.
Tutto sommato, aveva una bella figura ma aveva il vezzo di vestire con abiti che gli stavano assai larghi, sicché sembrava molto più grasso e più basso di quello che non fosse.
Glielo feci notare quando ero ragazzina e lui replicò:
Mi me piaze star bèo comodo, no co quee braghe tute ciuciarèe che i porta i to amissi! (“Mi piace star bello comodo, non con quei pantaloni stretti stretti, che indossano i tuoi amici!”).
Ma la cosa più intrigante di mio padre era il suo volto dai lineamenti marcati, ma che avevano una loro regolarità. Gli occhi erano scuri e profondi, le labbra vermiglie e tumide, la carnagione olivastra, la pelle senza una ruga e la capigliatura corvina foltissima, che, pur cominciando appena a diradarsi con gli anni, non diventò mai bianca ma s’ingrigì tardissimo e rimase sempre sontuosa.
Aveva un qualcosa di decisamente non-europeo: da giovane lo avresti detto un messicano piacente e, da più attempato, un fascinoso medio-orientale.
Insomma, era e rimase sempre un bell’uomo e non ho mai conosciuto nessuna donna, dai due ai novant’anni, che l’avesse conosciuto, che non stravedesse per lui.
Ma questo era dovuto, più che al suo sembiante, ai suoi modi: impossibile essere più “cavaliere” di lui. Sia chiaro che la sua galanteria non aveva mai nulla di viscido, perché era totalmente priva di secondi fini. Prova ne sia che lui era soccorrevole anche con donne molto anziane e oramai poco guardabili.
Per lui la donna era una creatura che andava rispettata per partito preso (L’omo ga da essare sempre cavaliere!). Rispettata ma anche perdonata perché, sempre a suo avviso, spesso capricciosa e irragionevole.
(Quanto a me, credo che non mi considerasse una donna vera e propria: mi diede un’educazione assolutamente maschile, ma di questo a suo tempo).
Io ero agli antipodi del suo ideale di bellezza femminile: troppo magra.
E non si faceva scrupolo di dirmelo chiaro e tondo:
La carne consa l’osso: Maria, te me fè pecà! (“La carne condisce l’osso: Maria, mi fai pena!”).
Ma io non me la prendevo, perché era di altro tipo la stima che volevo da lui.
A lui piacevano, le donne prosperose, ancor meglio se alte e alquanto imponenti, ma con un viso che non avesse nulla di volgare.
C’era un’unica attrice che incarnava in pieno il suo ideale di bellezza e di eleganza ed era Ingrid Bergman. Per lui era il massimo.
Vedendo il grande successo che lui aveva con quello che, allora, veniva definito “il gentil sesso” io, che avevo sempre problemi ad andar d’accordo con mia madre, sognavo che lui mi confessasse almeno qualche sua infedeltà coniugale. Mi sarei accontentata persino di una sola scappatella.
Per me era impossibile che non ci fosse stata, specie nel soggiorno goriziano, quando a casa lo si vedeva molto poco e, con la scusa di far benzina a buon prezzo, sapevo che andava in Jugoslavia ogni santo giorno. E lì, con tutte quelle donne piene di fascino slavo e assai più disinibite delle italiane, voleva darmi da bere di non aver mai combinato nulla? Non ci potevo credere.
Niente da fare! Lui negava sempre.
Insisteii soprattutto nei suoi ultimi anni, dicendogli che ormai eravamo vecchi tutti due e che, quindi, poteva essere finalmente sincero con me: non ero più la bimba di un tempo che sognava conflitti insanabli tra i suoi genitori e, perciò, poteva star sicuro che poi non lo avrei mai spifferato a mia madre.
Ma lui continuava a negare.
Inoltre, io sapevo che, prima dell’otto settembre, ossia nei primi anni quaranta, era stato di stanza ad Atene e aveva fatto parte della mitica Armata S’agapò (letteralmente: “Ti amo”, unica frasetta di neogreco che i soldati italiani pare conoscessero), Armata che vantava conquiste di fanciulle elleniche a bizzeffe.
All’epoca, mio padre era tra i ventitré e i e ventiquattro anni, per di più, faceva parte di un esercito occupante, possibile che fosse rimasto sempre casto e puro?
Alle mie proteste di incredulità, lui, alla fine sbottò:
‘Staltri gavarà fato, mi no’ go fato un tubo, parché gero el più ebete! (“Gli altri avranno concluso, io non ho fatto un bel niente, perché ero il più stupido!”).
E qui mi dovetti arrendere, constatando che quelli che l’avevano trattenuto non erano stati certo scrupoli morali, né tantomeno religiosi, bensì la sua scarsissima autostima, unita alla non-consapevolezza, da giovane ma anche in seguito, del suo grande charme.
Per dirla tutta, mio padre era un timido.
6. Ho avuto due padri.
L’assoluta centralità della figura paterna nella mia vita affonda le sue radici nei miei primi tre anni di vita, che trascorsi in una sorta di famiglia allargata. I miei genitori, infatti, non andarono a vivere subito per conto loro ma abitarono per qualche anno assieme ai genitori di mia madre.
In quella grande casa c’erano i miei due nonni ma anche il fratello minore di mia madre, che, quando nacqui, aveva solo ventitré anni. Ed era stato proprio quel mio zio, che già conosceva mio padre, a presentare sua sorella a colui che sarebbe diventato il suo futuro cognato.
La cosa buffa e singolare era che quel mio zio non solo si chiamava come mio padre (Mario), ma anche che, pur non essendo per nulla suo parente, aveva una sorprendente somiglianza fisica con lui.
Stessa statura, stessa corporatura, stesso tipo di chioma, stessa pettinatura “alla Mascagna” e, soprattutto, stessa forma dei baffi e della barba. Questa cornice di peli ben curati metteva in secondo piano, e quasi cancellava, alcune differenze, che pure esistevano nei lineamenti: più marcati quelli di mio padre e più affilati quelli di mio zio.
Mio padre aveva tre sorelle e nemmeno un fratello, forse ne sentiva la mancanza, fatto si è che andava d’accordissimo con quel cognato.
Crebbi, perciò, letteralmente circondata da mio padre e da una sorta di suo doppio, più giovane, con un carattere molto più affettuoso di lui, doppio che mi viziava come nessun altri mai.
Mio zio Mario, all’epoca, era già fidanzato e io mi ero guadagnata l’antipatia – che dopo le nozze cessò – della sua futura sposa perché, ogni sera, ad una certa ora, lei veniva piantata in asso dal moroso, che correva a casa ad imboccarmi, altrimenti io mi rifiutavo di mangiare la frutta cotta. Ho sempre detestato la frutta cotta, le mele in particolare, che mia madre m’imponeva, e io mi sottomettevo a tale tortura solo se era lo zio a reggere il cucchiaino e persuadermi con dolcezza che mi faceva bene.
Finita la cena, già da piccolissima ero nottambula e non volevo assolutamente essere messa a letto, ma pretendevo di restare alzata con gli adulti, che non erano pochi: arrivavano ogni sera due o tre amici dello zio.
I ragazzi si mettevano a giocare a carte e anche mio padre e mia madre partecipavano alle partite.
Serate che non posso ricordare, se non assai confusamente, ma che mi furono in seguito raccontate nei dettagli dallo zio, che ebbe poi figli, molti nipoti e bisnipoti ma che conservò sempre una preferenza particolare per me.
Per il mio diciottesimo compleanno zio Mario mi regalò un autentico sigaro Avana, racchiuso in bella custodia.
Lo zio mi riferì che io me ne stavo buona buona, seduta sul mio seggiolone, senza fiatare e che seguivo con occhietti attenti quegli strani maneggi con le carte, che non comprendevo ma che avevano su di me un fascino ipnotico.
In quelle lunghe e simpatiche serate si giocò tutto il mio futuro destino di bambina, e poi di adolescente, poco a suo agio con i propri coetanei, di cui nei primissimi anni di vita ignoravo quasi l’esistenza.
Venivo messa a letto solo quando ci andavano tutti gli altri: dopo che gli ospiti avevano preso commiato.
A quel punto, mio padre mi recitava buffe filastrocche e, appena poté, delle fiabe, di cui conservo ancora una vaga memoria. E io finalmente, cullata dalla sua bella voce, mi addormentavo beata.
7. Mio padre era bonario?
La storia de ea peíssa dipinge mio padre sul punto di perdere di brutto le staffe.
Tuttavia, quella fu una delle rarissime eccezioni in cui lo vidi così “nero” perché, di solito, mio padre non s’arrabbiava mai!
Era più facile che ridesse.
Lui aveva un carattere estremamente pacifico: odiava la violenza, in primis quella fisica, i litigi, gli insulti, specie quelli sboccati e detestava le scenate di qualsiasi tipo. Pensava che quelli che urlavano fossero degli incivili e dei totali bifolchi (dei gran boári) e se ne teneva lontano come dalla peste.
A chi lo conosceva solo superficialmente poteva sembrare un buono, un “volemmose bene”, ma chi lo conosceva come lo conoscevo io, non si lasciava ingannare.
Io sapevo che mio padre, nel profondo, era spietato.
Bastava assistere alle imitazioni di certi parenti e di quei conoscenti che non sopportava, imitazioni mirabili della voce e dei modi di muoversi di colui o colei che voleva irridere, per capire quanta perfidia poteva celarsi dietro il più bonario dei sorrisi di mio padre, dietro alla sua presunta tolleranza.
Ma lui si produceva in tali caricature esclusivamente in famiglia e, delle volte, solo a beneficio della sottoscritta: tutti gli altri ignoravano la portata del suo humour corrosivo.
Conoscendo il mio carattere insofferente, sempre pronto a insorgere per la prepotenza, per l’ignoranza, per la cafonaggine altrui, lui interveniva per calmarmi con una sua tipica raccomandazione, apparentemente bonacciona ma, in realtà, perfida:
Pico(e)a, no’ stà a ciapártea par queo là… poaréto! (“Piccola, non prendertela per quello là… poverino!”).
La motivazione arrivava subito dopo:
Tanto nol ghe riva! (“Tanto è tardo di comprendonio!”).
Insomma, intendeva dirmi che arrabbiarsi con chi, o per colpa di chi, non avrebbe mai capito nulla, no, non ne valeva la pena!
La vera questione era quanti fossero, ai suoi occhi, quei “poveretti” che facevano infuriare me e non lui, che era ben più lucido e più saggio di me.
Semplicemente si trattava della quasi totalità del genere umano verso il quale mio padre non nutriva illusione alcuna.
E va precisato, che quello che più non gli piaceva non era tanto la cattiveria quanto l’ottusità e la stupidità. Nemmeno i parvenu e gli sbruffoni con mania di grandezza (i grandessóni) poteva sopportare.
Mio padre aveva un metodo sicuro per prendere le sue distanze – e per farle prendere a me – da chi “non ci arrivava”: la sua capacità di trovare sempre una battuta feroce e fulminante che metteva fine ad ogni dissidio, dissolvendolo in una risata liberatoria. Una battuta indelebile che, però, bollava a vita il malcapitato.
Ricordo un piccolo episodio, in sé insignificante, ma che è altamente esplicativo di tale modus operandi.
Ero al primo anno di Filosofia e seguivo un seminario di un giovane assistente di un bravo professore, con cui volevo sostenere poi un esame. L’argomento era Hegel e quell’assistente era oltremodo fanatico di questo filosofo. Ogni volta che qualche studente tentava di trovare qualche falla nel sistema hegeliano, quell’assistente insorgeva, perdeva le staffe, scivolava nel dialetto veneto e apostrofava il malcapitato con un: Tasi! Tanto Hegel gavéva previsto anca ea to obiessión! Parché da Hegel no’ se esse! Come goi da dirveo? Da Hegel no’ se esse (“Sta zitto! Tanto Hegel aveva previsto anche la tua obiezione! Perché da Hegel non si esce! Come ve lo devo spiegare? Da Hegel non si esce!”).
Una frustrazione tremenda per noi poveri studenti, che eravamo alle prime armi nelle dispute filosofiche e che avremmo amato, invece, una vera discussione con vere argomentazioni e non questo reiterato sfoggio di dogmatismo!
Raccontai la cosa per filo e per segno a mio padre, sempre molto curioso delle mie prime esperienze universitarie.
Lui non fece commenti.
Non so come, giorni dopo, era in città e si appostò vicino alla porta principale del palazzo universitario, dove si teneva quel seminario – lo fece quell’unica volta e dopo mai più – e mi vide uscire assieme ad altri studenti e qualcuno appena un po’ meno giovane. E mi guardò, senza salutarmi. Capii che voleva mantenere l’incognito; mi lanciò poi una certa occhiata che mi poneva una specifica, muta, domanda:
Xéo quéo? (“È quello?”).
Annuii appena col capo.
Mio padre se ne andò via subito.
A casa, lui mi aspettava con un gran sorriso stampato sulle labbra:
Ciò, lo go vardà, ma queo nol ga miga la facia da fiosofo! El ga ‘na facia da pescador de bisáti! (“L’ho guardato, ma quello non ha per niente la faccia da filosofo, ha la faccia di uno che pesca anguille”).
Scoppiammo a ridere tutti e due.
In casi come quelli, il mio commento era sempre:
– Papà, sei tremendo! Ovvero una lode entusiasta.
Il sottinteso della frase di mio padre era che era assurdo ch’io attribuissi un qualche prestigio intellettuale a quel tizio e che, quindi, me la prendessi se costui soffocava ogni mio, e altrui, tentativo di argomentare, visto che aveva scritto in faccia che come filosofo nol vaeva ‘na cica (“non valeva niente”).
Direte che mio padre era un seguace di Lombroso e che giudicava le persone in base alla conformazione del loro volto, ebbene sì lo era.
E non si sbagliava mai.
Per il resto di quel seminario, feci una fatica enorme a soffocare delle risate che mi covavano dentro e che, in piena aula, sarebbero risultate maleducate e inopportune.
Poco da fare, mentre costui si spolmonava su Hegel, io me lo vedevo con una faccia da fesso, appostato per ore in qualche squallido canale, con la lenza in mano, in attesa che abboccasse una povera anguilla, la quale, magari, sognava il Mar dei Sargassi.
Uno studente, seduto vicino a me, si accorse che, durante quelle lezioni, avevo sempre una ridarella repressa e me ne chiese la ragione. Al che, non potei trattenermi e gli raccontai dell’uscita di mio padre. Ovviamente, quella battuta fu subito divulgata ed ebbe un enorme successo, perché tutti la trovarono azzeccatissima.
Ma non è finita qua: quel docente, allora alle primissime armi, fece presto carriera e, anni dopo, quando diventai Ricercatore di Filosofia, mi capitava di incontrarlo quasi tutti i giorni. Ebbene, per ben sette lustri di seguito, ogni volta, all’uomo presente dinanzi a me, che ormai godeva di un certo prestigio, si sovrapponeva il suo ridicolo fantasma che pescava anguille.
E volete saperla davvero tutta? Finii per domandare ad un mio collega, che era amico intimo del tizio, se costui che, tra l’altro, si gloriava delle sue performances di sub, avesse mai praticato in gioventù quel particolare tipo di pesca e la risposta fu affermativa.
Mio padre ci aveva visto giusto!
8. Mio padre prigioniero.
Devo ora cominciare a raccontare di un’esperienza fondamentale che mio padre fece quando era ancora piuttosto giovane, ossia tra i ventiquattro e i ventisei anni: la dura prigionia in un campo di internamento tedesco.
Quegli anni cruciali incisero profondamente sul suo carattere e sulla sua visione del mondo, oltre che sui suoi comportamenti quotidiani, anche i più spiccioli, quali il suo rapporto col cibo, il sonno etc.
Affronteremo questi argomenti caso per caso.
Intanto va spiegato come mio padre finì in un campo di internamento, alludendo brevemente agli antefatti.
Era rimasto orfano di padre mentre ancora faceva il liceo classico e colei che esercitava la maggiore autorità in famiglia era sua sorella Ada. Quella mia zia aveva il diploma magistrale e manteneva tutti, ossia sua madre, due sorelle e mio padre, che era il secondogenito, facendo, appunto, la maestra. Nel frattempo, siccome era una donna geniale, dopo aver sostenuto un esame per integrare il suo diploma, s’era iscritta a Matematica, in cui poi si laureò brillantemente e che insegnò con gran passione tutta la vita.
La zia Ada aveva, insomma, una mentalità scientifica e trovava disdicevole che il fratello minore, unico maschio rimasto in famiglia, s’iscrivesse a Lettere, come lui avrebbe desiderato. Lo costrinse, allora, a optare per Chimica. Una vera tortura per mio padre, così amante della poesia e della Storia dell’arte. Forse non riuscì a superare nemmeno il primo esame, anche se mio fratello sostiene che uno almeno lo fece.
In ogni caso, allo scoppio della guerra, gli studenti di chimica erano veramente molto pochi in Italia e mio padre si trovò, senza nessuna raccomandazione, a far parte di una ristretta élite di privilegiati. Fu così spedito a Roma alla Cecchignola: una caserma esclusiva.
Da Roma fu poi mandato ad Atene, dove, a sentir lui, aveva passato circa un paio d’anni bellissimi.
Non prese mai parte, in tutta la durata del conflitto, a nessuna operazione bellica e, nella capitale greca, in qualità di sottotenente, alloggiava in uno splendido hotel (il “King George”, in piazza Sintagma) e aveva libero accesso ai migliori ristoranti. Non disponeva di denaro contante, ma godeva di quello che ogni gentiluomo d’altri tempi poteva desiderare al sommo grado: un credito illimitato.
Adesso forse cominciate a capire meglio certe posizioni radicali di mio padre sul suo rifiuto del lavoro e sul vivere di rendita…
Tutte le sere, si recava in un locale notturno di sua scelta e assisteva alle danze, senza però prendervi parte.
Diceva sempre di sé, nei momenti di particolare disistima:
Mi, no’ so’ un omo completo! (“Io non sono un uomo completo”).
E lo diceva sempre con rammarico e con un gran sospiro.
– Ma perché, papà?, gli chiedevo:
Parché no’ so ba(e)are (“Perché non so ballare”).
Era figlio di una tosco-emiliana, gente che ama le danze sopra ogni altra cosa e, timido com’era, si contentava di guardare gli altri ballare, spettacolo che non lo annoiava mai.
Il periodo, spensierato e dorato, di Atene finì bruscamente l’otto settembre del ‘43.
Mio padre non aveva allora alcuna coscienza politica, ma non era nemmeno interessato al Fascismo, per cui non capì affatto la portata del comunicato del generale Badoglio che, del resto, tanto chiaro non era.
Ne dedusse solo che la guerra era finita e che per lui era tempo di tornare in Italia.
Salì su un taxi e si fece portare in stazione, convinto di poter prendere un treno e arrivare, prima o poi, a casa.
Pare che i soldati tedeschi, che lo spinsero su quel treno, gli avessero detto, mentendo, che la destinazione era l’Italia.
Nel lungo lasso di tempo in cui lui attraversò i Balcani, gli fu dato solo un filone di pane e un pezzo di margarina, che mio padre mangiò sconsideratamente subito, sicché digiunò per almeno cinque giorni, se non di più.
Nel pavimento del treno, trovò un fagiolo secco e lo succhiò per tutto il tempo non sapendo ancora bene che cosa lo attendesse.
E così, senza che all’inizio se lo potesse immaginare, si trovò prigioniero in un campo nella Polonia occupata, non lontano dal confine russo. In seguito, fu trasferito in Germania.
Si può dire che da Atene alla prigionia non vi poteva essere mutamento più drastico.
Siccome era ufficiale e i tedeschi avevano il senso della gerarchia, quando veniva trasferito da un campo all’altro, non veniva sbattuto in un carro merci, come accadeva alla truppa, ma viaggiava in un normale scompartimento, in mezzo a passeggeri tedeschi. Durante il viaggio, era costantemente sotto tiro della rivoltella di chi lo aveva in custodia.
Sarà stata l’aria pacifica e imperturbabile di mio padre, fatto sta che non era raro che qualcuno dei viaggiatori gli offrisse una sigaretta.
E, per un fumatore accanito come lui, era dono graditissimo.
Tali atti gentili si ripetevano, ogni tanto, quando mio padre nell’ora d’aria, poteva passeggiare brevemente in spazi rigorosamente delimitati dal filo spinato, anche in quel caso, c’era stato qualche contadino tedesco che, a rischio di ricevere una pallottola dalle sentinelle, gli allungava una sigaretta. Uno gli aveva perfino stretto la mano.
Questi gesti maturarono in lui la convinzione che i nazisti fossero una piccola minoranza di delinquenti ma che i tedeschi fossero, invece, una popolazione di buon cuore.
Mio padre era in questo decisamente controcorrente rispetto al sentire comune che, nel dopo-guerra, ma anche negli anni successivi, tendeva a dire e a pensare peste e corna dei tedeschi.
Probabilmente, mio padre ammirava i tedeschi perché lui era esattamente il contrario rispetto a loro. Ad esempio, era molto disordinato con gli oggetti, non amava fare nessun tipo di programma, ma preferiva decidere al momento. Non esisteva nella sua vita, nessun tipo di “organizzazione”.
Oddio, anche i campi di sterminio erano organizzati a meraviglia, ma di questo non ha senso parlare qui…
Per tutta la sua esistenza, mio padre studiò con zelo la lingua tedesca, e ogni tanto seguiva dei corsi anche se, a dire il vero, non fece mai progressi significativi.
Era divertente quando si appartava in salotto esercitandosi a voce molto alta con una grammatica tedesca in mano, mettendo involontariamente in fuga la nostra attempata donna di grosso, la mitica signora Michelón. Costei, che pure era innamorata persa di mio padre (To popà, xé un omo reae!, “Tuo papà è un uomo regale!”, mi diceva in continuazione) era terrorizzata da quelle teutoniche sonorità, che le evocavano gli ordini urlati della Gestapo, che mio padre detestava quanto lei, ma che avevano finito per influenzare la sua perentoria pronuncia.
Di conseguenza, mio padre trovava da ridire che io m’interessassi ai filosofi francesi piuttosto che a quelli tedeschi (Xé quéi i veri fiosofi! “I veri filosofi sono quelli!”), cosa che mi era impossibile foss’altro per le dosi troppo massicce di Hegel, ma anche di Kant e di Heidegger, che mi sorbii nei primissimi anni di università.
Dopo che ebbi conseguito la Maturità, mio padre non si mostrò nemmeno contentissimo che mi fossi iscritta a Filosofia e non a Lettere, cosa che lui poté fare solo di ritorno dalla guerra, ma siccome era tutt’altro che autoritario e sapeva bene cosa significasse subire pressioni nella scelta di una facoltà, non mi ostacolò.
Manca un altro dettaglio storico fondamentale.
Dopo che fu fatto prigioniero, proposero a mio padre di aderire alla Repubblica Sociale, cosa che gli avrebbe permesso di uscire dalla prigionia immediatamente .
Mio padre rifiutò e per due anni fu sballottato da un campo all’altro.
9. Mio padre e il cibo.
Dopo il rifiuto di aderire alla Repubblica di Salò, cominciarono per mio padre gli anni della grande fame.
Lui, che amava moltissimo le battute paradossali, sosteneva che in prigionia ci stava benissimo, noi figli protestavamo perché ci pareva che dicesse una grande sciocchezza.
Al che lui, con aria da finto tonto, rispondeva:
Se capisse! No’ fasevo un tubo tut’al dì, no’ lavoravo, go conossúo zente inteigente, se parlava… (È chiaro che è così! Non facevo nulla tutto il giorno, ho conosciuto gente intelligente, si parlava…”).
Gli obiettavano che aveva patito tantissima fame. E, su questo, era assolutamente d’accordo.
Eravamo curiosi di sapere in che consistesse il suo regime alimentare. E ce lo svelò. La mattina veniva data ai prigionieri una brodaglia di caffè di cicoria, che mio padre non beveva e che, essendo caldina, usava per radersi, rito quotidiano che per lui era sacro – e tale restò per tutti i giorni della sua vita – e cui non avrebbe rinunciato nemmeno se fosse stato all’ergastolo.
Ho sempre apprezzato questo suo puntiglio a non abbrutirsi, a cercare di rendersi il più presentabile possibile. Del resto radersi era l’unico tipo di toilette che poteva permettersi, perché i tedeschi concedevano ai prigionieri solo una doccia (gelata) alla settimana, dopo la quale si rimettevano gli abiti sporchi di prima, che dopo un po’ assumevano una rigidezza metallica.
Ad ora di pranzo, arrivava una marmitta di patate lesse. Ne toccava una testa.
E qui c’era un rituale complicato e rigorosissimo che i prigionieri avevano escogitato per soffocare qualsiasi istinto di sopraffazione tra di loro.
A turno, ogni giorno, in rotazione, veniva cambiato colui che distribuiva le patate, che non erano tutte di eguale grandezza, sicché chi le assegnava si doveva servire per ultimo, con il tacito accordo che a lui toccasse la più piccola.
Una cerimonia analoga veniva inscenata con una pagnotta, che non era certo di forma perfettamente geometrica: anche in quel caso, c’era uno che tagliava le fette a turno, ne assegnava una a testa e l’ultima era per lui.
Per quanto possa sembrare incredibile, a sentire mio padre, non c’erano rimostranze, né discussioni. Insomma, tutto si svolgeva in sfregio a Hobbes, il quale sostiene che, nello stato di natura, homo homini lupus (“ogni uomo è un lupo per un altro uomo”), ossia si scatena il bellum omnium contra omnes (“la guerra di tutti contro tutti”).
Il fatto è che, nelle varie baracche in cui finì mio padre, non vigeva uno stato di natura quanto, casomai, di cultura. Infatti, dato che tutti i suoi compagni erano ufficiali, lui poté godere della compagnia di studenti e talora di docenti universitari, di futuri attori e futuri scrittori, alcuni dei quali divennero poi piuttosto noti. Insomma, erano tutti degli “intellettuali” e, a sentir lui, cercavano di comportarsi civilmente.
Riflettendoci, il motivo per cui mio padre non vedeva di malocchio la prigionia, o quanto meno se la faceva piacere e, in qualche modo, nel ricordo la idealizzava, era che creava un mondo utopico, un mondo fuori dal mondo. E a mio padre il mondo “normale”, non piaceva affatto.
Per continuare con la dieta dei prigionieri, oltre una patata e una fetta di pane, venivano loro dati, ogni giorno, pochissimi fagioli secchi.
Mio padre raccontava che un simpatico studente di medicina, essendosi procurato una specie di gessetto, aveva disegnato sul pavimento della baracca un intestino umano, che è lungo circa sette metri. Il futuro medico aveva poi posizionato gli sparuti legumi in fila, nelle anse, a circa un metro di distanza l’uno dall’altro, e aveva concluso che mai e poi mai si sarebbero potuti saziare con una simile miseria. Era scoppiato a ridere e mio padre con lui.
A qualcuno venne in mente che si sarebbero potuti giocare quei fagioli; non so come, i reclusi si procurarono delle carte e vennero organizzate delle partite di poker. Alla fine, però, chi vinceva, e accumulava un bel mucchietto di legumi, non se li teneva per sé ma li metteva in comune, in modo da aggiungerli, ogni tanto, all’annacquatissima sbobba con cui i prigionieri cenavano. Il vincitore, insomma, si riservava il piacere di essere munifico.
Credo che in ogni baracca ci fosse anche una stufa, con un fuoco stentato, dove, su una latta di fortuna, si potevano cuocere i fagioli.
Su questo particolare mio padre restava sul vago. Non ci disse mai nemmeno in quanti erano in media dentro ogni baracca.
Gli domandavamo se i prigionieri, sottoposti ad un’alimentazione così scarsa, si ammalassero e lui rispondeva categorico che mai nessuno stette male – e, ripensandoci, non so se credergli. Certo, erano tutti molto dimagriti e molto deboli ma facevano in modo di non sprecare le forze. Così se ne stavano la maggior parte del tempo sdraiati sui loro letti e la loro attività principale era parlare e parlare.
Ma di cosa parlavano? Non pensiate che parlassero granché dei loro fatti personali, delle morose che avevano lasciato in Italia o di quelle che avrebbero voluto avere o di cose del genere, no, l’argomento principe era uno solo: che cosa si sarebbero mangiati una volta tornati a casa.
E qui entra in gioco una particolare categoria di prigionieri che mio padre prese ad amare moltissimo: i napoletani.
Costoro, dotati di una favella fluida quanto sontuosamente immaginifica, erano insuperabili nel descrivere cosa avrebbero richiesto per il loro primo pasto da uomini liberi.
Ascoltandoli, i prigionieri trovavano un grande sollievo ai morsi della fame e ponevano domande a quei maghi della parola, i quali giocavano al rialzo nell’evocare piatti sempre più succulenti.
Mio padre rimase estremamente affascinato dalle sonorità partenopee, imparò subito il loro idioma e, per tutta la vita, se ne usciva spesso in spassosissimi proverbi o storielle nella lingua di Salvatore di Giacomo, che aveva appreso da quei suoi compagni di baracca.
Sapeva, inoltre, a memoria, parola per parola, il testo di moltissime canzoni napoletane classiche, che ogni tanto cantava con molto sentimento, nonostante non fosse intonatissimo.
Io, naturalmente, gli davo corda e cantavo assieme a lui.
Insomma, vi assicuro che il suo accento napoletano era perfetto, me ne resi conto quando visitai Napoli. Ma anche molto prima, già da piccola, quando mio padre, che pure non era un patito della televisione, non si perdeva – e non faceva perdere ai suoi figli – una commedia di Eduardo de Filippo o un film di Totò – suoi idoli assoluti.
La fame patita in prigionia aveva lasciato tracce indelebili nel suo rapporto con il cibo. Aveva un appetito formidabile e di ogni piatto voleva il bis.
Mangiava grandi quantità di pane e con questo alimento faceva cose strane: tendeva a non spezzare mai una pagnottella per primo, ma aspettava che qualche altro dei familiari lo facesse e, con grande naturalezza, gliene sottraeva metà e la portava vicino al suo piatto.
Al che, quando ero piccola, m’irritavo e gli facevo notare che era troppo avido e che quello non era un comportamento tanto educato. Ma presto capii che lui non si rendeva affatto conto di tali “furti”, che gli venivano in automatico.
Si era troppo represso nell’aspettare con pazienza il suo turno quando era prigioniero e, per tutto il resto della vita, non poteva non rifarsi.
La sua capacità di digerire senza problemi anche cibi pesanti – non certo cucinati da mia madre che li detestava, ma in altri contesti – era sorprendente.
Di conseguenza, prendeva in giro chi aveva problemi di gastrite o di colite, che lui non sapeva nemmeno cosa fossero.
Io, che in questo non gli somigliavo nemmeno un poco, lo invidiavo moltissimo.
E, ogni volta che mi vedeva esitare davanti a qualcosa che mi tentava e che temevo poi m’avrebbe dato del filo da torcere, mi esortava ruvido e beffardo:
Magna, pico(e)a! Magna! Che almanco po’ te staré mae par calcossa! (“Mangia, piccola! Mangia! Che almeno dopo starai male per un motivo valido!”).
Purtroppo la sua carriera di sano divoratore ebbe un pessimo epilogo: lui, che digeriva anche i sassi, morì di tumore allo stomaco.
Venni poi a sapere da un medico di fiducia che almeno il quaranta per cento di quelli che erano stati in prigionia, e avevano pressoché digiunato per un paio d’anni, morivano, anche a gran distanza di tempo, proprio di quel tipo di cancro.
10. Mio padre e il gioco.
Ignoro se mio padre imparò a giocare a poker in prigionia o ancor prima, ma vi posso assicurare che, in questo gioco, era un vero fuori classe; me ne insegnò le regole che non avevo dieci anni.
Lui, di solito così bonario ed ilare, con le carte francesi in mano, diventava serissimo e glaciale.
Non succedeva, invece, con le carte italiane, con le quali teneva un atteggiamento molto più rilassato. Son rimasti leggendari, tra i miei parenti appenninici, i suoi spassosi Ciápa! Ciápa! (“Prendi! Prendi!”), con cui incitava il suo compagno di briscola.
Se, invece, si giocava a poker, pretendeva che venissero dette solo le parole rituali esatte – ad esempio, “Distinguo”, ha un significato diverso da “Vedo” – e non parole a casaccio o, peggio, superflue.
Per il resto, doveva regnare il più assoluto silenzio.
Si seccava moltissimo se qualcuno si lamentava di avere una giornata sfortunata e mi diceva sempre:
– Il gentiluomo si riconosce al tavolo di gioco!
E lo diceva in italiano! Cosa che sottolineava la perentorietà di tale affermazione.
Assumeva un volto completamente inespressivo e voleva che tu fossi sempre incapace di decidere se avesse una fortuna sfacciata o se, invece, fingesse di avere chissà quale gioco servito o arrivatogli dopo il cambio di certe carte.
Per andare a vedere cosa aveva in mano, dovevi sudare sette camicie, perché tendeva a rialzare le puntate a poco a poco e a trascinare l’avversario fino a spennarlo.
Quando poi tu rinunciavi a seguirlo, lui, alla fine, ti mostrava solo la sua coppia di apertura, affermando che era tenuto ad esibirti solo quella.
Se, ad un certo punto, perdevo la pazienza – ero ancora una ragazzina – e voltavo di prepotenza le sue carte, dopo che lui aveva vinto l’ennesima mano, si arrabbiava per davvero e smetteva di giocare.
Tuttavia, mio padre non aveva il demone del gioco: non voleva assolutamente che si puntassero soldi, ma solo fagioli – e adesso potete capire perché proprio fagioli – che non assumevano mai il valore di fiches.
Insomma, era interessatissimo al rituale del poker, alla tacita guerra psicologica, ma certo non a guadagnare denaro.
La vincita, la perdita e l’azzardo per lui esistevano eccome, ma erano puri concetti “metafisici”.
I vertiginosi e aridi giochi al computer, che si usano adesso, ma anche tutte le forme di poker cronometrato, gli avrebbero fatto schifo e orrore.
Purtroppo, non ebbi moltissime occasioni di vedere mio padre all’opera come virtuoso del poker. O, meglio, lo vidi a iosa quando ero ancora incapace di pensiero razionale, ovvero nei primi tre anni di vita, nelle serate con mio zio Mario e i suoi amici, dove credo si giocassero anche altri tipi di partite.
Lo potei ammirare come pokerista – ma tutto sommato non tantissime volte – in montagna, quando giocavamo coi suoi cugini.
E lui vinceva quasi sempre.
Visto che ero una giocatrice non eccelsa, la cosa che mi piaceva di più era stare fuori dal tavolo, piazzarmi a sedere dietro di lui: così potevo godere appieno lo spettacolo della sua strategia. Lui mi tollerava come spettatrice, a patto che non muovessi un muscolo, non facessi commenti, né prima, né durante, né poi.
Ecco perché ora vi posso dire che mio padre era un principe del bluff.
11. Mio padre e il sonno.
Ho sempre sofferto d’insonnia e, se c’era una cosa che invidiavo di mio padre, era il suo splendido rapporto con il sonno; la sua capacità di addormentarsi profondissimamente appena posata la testa sul cuscino non cessava di stupirmi.
Probabilmente in prigionia il sonno avrà rappresentato per lui una via di fuga.
Ma, secondo me, c’era dell’altro: mio padre poteva dormire a comando grazie al rapporto pienamente sereno che aveva con se stesso: per la sua saggezza.
La mattina, anche se non era costretto a farlo per cogenti motivi di lavoro, tendeva ad alzarsi molto presto, persino se aveva tirato tardi la sera prima.
Mi ricordo una felice vacanza in Maremma con miei zii e cugini, in cui lui usciva dalla tenda, andava spedito verso il fornello da campo, si faceva un’enorme caffettiera, se la beveva tutta per poi avviarsi lieto per una passeggiata mattutina.
Non lo vidi mai assonnato, e meno che meno di malumore. Anzi, lui detestava quelli che si svegliavano male e con il muso lungo: li riteneva dei poveretti e dei grandi rompiscatole.
Appena desto, scandiva, in perfetto napoletano, il suo saluto programmatico al giorno nascente: Quanto me piace ammè la vita attiva! (“Quanto mi piace la vita attiva!”).
Sicuramente era un omaggio a qualche suo antico compagno di prigionia partenopeo. Ma non vi posso rendere la maniera spassosa in cui lo diceva e come mi mettesse di buonumore sentirlo sempre così pieno di voglia di vivere e allegro.
Anche quando andò in pensione, nei pochissimi anni in cui poté godersi l’affrancamento dal lavoro, non smise di alzarsi di buon’ora.
Usciva di casa il prima possibile e, se doveva fare qualche spesa di alimentari o una qualsiasi commissione burocratica, la concludeva tassativamente entro le dieci. Poi, depositato a casa ogni fardello, usciva ancora e girava libero per la città fino ad ora di pranzo, che non era mai dopo l’una.
All’una e mezzo era già in posizione orizzontale. La sua mise durante il riposo, era la medesima che adottava in casa: larghe braghe del pigiama a righe, dalla vita in giù e, nella parte superiore, camicia, gillet di lana senza maniche, cravatta allentata, che toglieva solo al momento di coricarsi la sera e passare alla giacca del pigiama.
Riposava, coperto appena da un leggero plaid e, siccome non era affatto freddoloso, i suoi piedi, perfetti senza nessuna callosità, emergevano nudi dalla copertina. Da bimba dispettosa qual ero, talvolta avevo provato a vellicarglieli appena appena con una lunga piuma ma, niente da fare, lui restava insensibile e non si svegliava.
Il suo regno per le pennichelle era un grande divano stile impero, detto in famiglia: “il transatlantico”, sito in uno degli ampi corridoi dell’appartamento.
Insomma, nel primo pomeriggio, dormiva in una zona di transito, non lontano dal telefono a parete e nessuno in famiglia si faceva molto riguardo di non fare rumore, tanto il suo sonno era di piombo.
Alle tre in punto, si svegliava sorridente, si faceva una bella caffettiera, se la beveva tutta e si riaddormentava, almeno per un’altra ora.
Nel resto del pomeriggio, spesso leggeva fino ad ora di cena.
Ovviamente, questo succedeva quando lavorava nella città di residenza o di domenica o, appunto, quando era in pensione.
La sua gestione del tempo era, invece, un po’ diversa quando era in vacanza sugli Appennini, dove tuttavia non saltava mai un pisolo pomeridiano ma dove, tutto sommato, era più attivo e si dedicava a varie riparazioni della casa avita, piuttosto malandata e sempre bisognosa di restauri.
Non disdegnava i lavori di muratura ma più di tutto amava usare i pennelli per tinteggiare le pareti ma anche i mobili.
In montagna faceva anche lunghe passeggiate per lo più da solo, ma non era raro che io lo accompagnassi.
Non andava mai a letto presto e, se trovava un libro di suo gradimento, era capace di leggerlo nottetempo fino alle ore piccole.