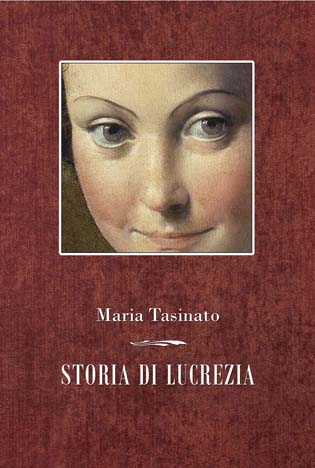12. Mio padre e la fantasia.
La vita di mio padre si giocava tutta in un singolare equilibrio tra staticità e attività.
Ma v’era, in ambo i casi, un trait-d-union: lui era un grande sognatore.
Sicuramente il campo d’internamento aveva accentuato questa sua caratteristica, che lo accompagnò poi costantemente, sia che stesse sdraiato a dormire o seduto a leggere, sia che passeggiasse o viaggiasse.
Già vi ho raccontato dei banchetti con l’immaginazione che i compagni di prigionia allestivano e, non a caso, lui soleva evocare un celeberrimo piccolo episodio di un film che lui amava moltissimo: Pane amore e fantasia di Comencini.
È la celeberrima scena in cui Vittorio De Sica, altro attore prediletto da mio padre, domanda ad un paesano che cosa stesse mangiando. Il villico ha in mano solo una pagnotta tagliata in due e De Sica (graduato salernitano dei Carabinieri) gli domanda cosa ci metta dentro e la risposta è: A fantasia, Marescià! (“La fantasia, Maresciallo”).
Questo scambio di battute estasiava mio padre, che era solito ripeterlo con un perfetto accento napoletano. E subito dopo commentava con un sorriso rapito: Che bèo, ciò! (“Ma che bello!”).
Ebbene, ho rivisto recentissimamente questo film, che fu girato in un paesino a ovest di Roma, dove gli abitanti si esprimono in un laziale con cadenze ciociaro-abbruzzesi, sicché ho potuto costatare che, nell’originale, la risposta suona semplicemente: Fantasia, Marescià! Ma per mio padre il cibo immaginario era rimasto per sempre una trovata partenopea.
Ero ancora molto piccola quando scoprii un’altra occupazione da sognatore di mio padre. Mi era capitato di vederlo assorto con una matita in mano tracciare una serie di segni, per me misteriosi, su dei fogli. Ad una mia domanda, mi spiegò che stava disegnando piante di case e spesso di ville, anche molto vaste. Erano dimore immaginarie che gli sarebbe piaciuto abitare.
E anche questo era relegato nel regno delle pure rêverie perché mio padre non agognava essere ricco ed era sommamente alieno da qualsiasi forma di invidia sociale.
Aveva ricevuto in eredità una piccola porzione della casa del suo nonno appenninico, che era piuttosto malmessa.
Quando passeggiava con me per i boschi spesso si fermava a guardare con interesse qualche rudere, in genere delle antiche costruzioni di pietra viva che un tempo erano stati essiccatoi di castagne e mi spiegava come avrebbe potuto restaurarle.
Allora avrebbe potuto benissimo comperare uno di quei “canicci” – è questo il vocabolo in tosco-emiliano dei “metati” per le castagne – per un prezzo irrisorio, persino alla sua portata. Fingeva di interessarsi su chi fosse il proprietario, ma poi non ne faceva nulla, solo disegni su disegni.
Non risparmiò mai nulla per poter acquistare una casa in città. L’ultima in cui abitò divenne di sua proprietà solo negli ultimi suoi anni di vita, perché era uno degli ultimi esemplari rimasti di casa a riscatto e mio padre, anche in quel caso, titubò non poco prima di approfittare di quell’occasione d’oro.
Imitai molto precocemente la mania di mio padre di disegnare le piante delle case e gli domandai come riprodurre sui fogli a quadretti le varie proporzioni.
Mi ricordo che, in prima elementare, la maestra chiese alle sue piccole alunne di disegnare ognuna la propria casa. Tutte le bambine, sia che abitassero in un condominio, o in una villetta, confezionarono un disegnino molto convenzionale con la stereotipata casetta dal tetto spiovente, le solite tendine alle finestre e l’immancabile camino fumante.
Io no, consegnai, con un certo orgoglio, la piantina precisissima dell’appartamento in cui abitavo, con l’ubicazione esatta delle finestre e delle porte persino col perimetro dei vari mobili.
Al che, mia madre fu convocata dall’insegnante e le fu detto che non ero una “bambina normale”. Invece di apprezzare l’esattezza della riproduzione in scala, la maestra, che era una suora, focalizzò la sua attenzione, e la sua riprovazione, sulla camera dei genitori, dove appariva il contorno del letto matrimoniale con in più due pallini, al centro dei cuscini, corrispondenti alle teste dei miei genitori.
Apriti cielo!
Mia madre ebbe il suo bel da fare a spiegare a quella creatura morbosa e repressa che io avevo come modello mio padre che disegnava sempre le piante delle case ma, in seguito, non mancò di rimproverarmi per quei due tondini, che, a suo dire, avrei potuto benissimo omettere.
Un’altra attività cui mio padre si dedicava inseguendo i suoi sogni ad occhi aperti era piuttosto buffa e poteva sembrare alquanto sconveniente.
Siccome era un fumatore accanito – tra parentesi, fumai la mia prima sigaretta a sette anni per imitarlo, ma poi non fui mai in grado di fumare più di una sigaretta al giorno, né tantomeno di aspirare il fumo – aveva uno stanzino a lui riservato dove si appartava a lungo. Era un angusto e gelido bagnetto con una finestrina con apertura a ribalta, che non veniva mai chiusa nemmeno in pieno inverno.
Mio padre, a meno che non dovesse espletare le sue funzioni fisiologiche, non chiudeva la porta a chiave e, dall’odore di fumo che si percepiva fin dal corridoio, fumava a più non posso.
Ma non faceva solo quello.
Se ne stava seduto sulla tazza, vestito, con in mano una sigaretta e, sulle ginocchia, uno opuscolo cui era affezionatissimo.
Quando ero ancora piccola, ero assai curiosa di scoprire cosa fosse quel libretto misterioso, pieno di cifre fitte fitte.
Era un orario ferroviario dove lui fantasticava su percorsi in treno che non avrebbe mai fatto.
Ancora alle elementari, m’insegnò a consultarlo, svelandomi la complicata strategia dei cambi e delle coincidenze.
Si divertiva a propormi destinazioni a me semi-sconosciute e a sfidarmi a trovare il modo più veloce per arrivarvi e, se non era soddisfatto delle mie soluzioni, me ne suggeriva di migliori. Sicché divenni presto abilissima a destreggiarmi in simili rompicapi.
Ancora adesso, come conseguenza di questi antichi trastulli ferroviari, non posso non nutrire un profondo disprezzo per chi viaggia esclusivamente in macchina e, in una stazione dei treni, resta tutta la vita un esitante pesce fuor d’acqua.
L’orario ferroviario, che mutava ad ogni passaggio tra l’inverno e l’estate e viceversa, dunque un paio di volte all’anno, veniva acquistato da mio padre in edicola il giorno esatto del cambio di stagione, anche se lui non aveva nessun viaggio in programma nell’immediato.
In mano a mio padre, l’orario ferroviario, così arido per un profano, diventava un avvincente libro d’avventure.
13. Mio padre viaggiatore.
Riguardo alle mie competenze in materia ferroviaria, mio padre non si limitò ad istruirmi solo sulla teoria ma mi insegnò molto presto cosa fare in una stazione: quali cartelli consultare e come cambiare binario senza problemi.
Voleva fare di me, fin da subito, una persona che non avesse alcun timore di perdersi, né in una stazione, né per strada.
Avevo otto anni quando, a metà dicembre del 1958, ci trasferimmo a Udine. Fino a quel momento, ero sempre andata a scuola da sola perché a Padova, per raggiungere le elementari che fino ad allora avevo frequentato, bastava che proseguissi per una cinquantina di metri sul marciapiede e poi attraversassi una strada. Certo mi si raccomandava di essere prudente, ma nessuno mi accompagnava, né mi veniva a prendere a scuola.
E, in questo, ero già un’eccezione rispetto alle mie coetanee, che erano sempre scortate da un adulto.
Il bello successe quando mi trovai improvvisamente in una città a me completamente ignota.
Mio padre mi accompagnò a scuola, avvertendomi:
Varda, pico(e)a, che no’ te podarò più compagnare ‘sco(e)a perché go tanto da fare in uficio: ocio a le strade che ciapémo. Da domàn te gavaré da farle da so(e)a! (“Bada, piccola, non potrò più accompagnarti a scuola perché ho da fare in ufficio: fai attenzione alle strade che prenderemo. Da domani dovrai farle da sola!”).
Me lo disse senza nessuna severità, semplicemente spiegandomi come stavano i fatti. Per tutti i miei spostamenti nella nuova città non potevo contare su mia madre, che doveva occuparsi di mio fratello, ancora molto piccolo e che allora soffriva di frequenti attacchi d’asma.
Non misi più piede ad Udine dal 1961 fino al 1980: dunque, avevo circa trent’anni quando vi ricapitai casualmente per fare una brevissima visita ad un mio amico che faceva là il servizio militare.
Per prima cosa volli ripetere, dopo quasi due decenni, il percorso tra la mia casa di allora e la mia scuola, che esisteva ancora.
Ero convinta che, come spesso accade nei ricordi degli anni della fanciullezza, d’aver ingigantito le distanze e, invece, rimasi sbalordita: si trattava di un tragitto davvero complicato, con vari cambi di direzione e ci misi più di un quarto d’ora per farlo tutto.
Sicché, sarò riconoscente per tutta la vita a mio padre, non solo per aver avuto sempre fiducia in me, ma soprattutto per avermi reso autonoma.
In generale, da che ho memoria, mi ha sempre trattata non come una bambinetta insipiente ma come se fossi già adulta.
Mio padre non viaggiava solo con la fantasia ma anche de facto. Purtroppo non lo fece moltissime volte assieme alla famiglia e, in quei casi, ho sempre ammirato la sua completa disinvoltura.
Per restare in tema di orientamento, ero esterrefatta come lui non si perdesse mai persino in una città di grandi dimensioni, che non aveva certo visto prima di allora, ad esempio Madrid. E sì che non si studiava preventivamente le mappe! Tuttavia sapeva sempre che direzione prendere, e a colpo sicuro.
Fu sempre lui ad insegnarmi a non smarrirmi nei dedali delle calli veneziane:
No’ sta a fissarte col nome dee cai: l’importante xé ea diressión! (“Non devi fissarti col nome delle calli: l’importante è la direzione!”).
Quando facevo la seconda media, in marzo, mi tenne una decina di giorni a casa da scuola – credo che ebbe un’accesa discussione con una mia insegnante – e mi portò, assieme a mia madre e mio fratello, che allora andava ancora all’asilo, a visitare Siracusa e Taormina.
Allora il viaggio in treno da Padova a Siracusa era abbastanza avventuroso: durava più di ventiquattr’ore.
Mio padre era al settimo cielo ed entusiasta della Sicilia.
Dai 47 ai 60 mio padre ebbe notevoli problemi di vista a causa di una cateratta anomala che nessun chirurgo, anche di fama internazionale, s’azzardava ad operare.
La perdita della vista fu progressiva, ma presto lui non poté più guidare e poi quasi più leggere. Andava avanti a gocce di atropina, di cui abusava, e che gli facevano un effetto sempre più breve.
Tuttavia, non si muoveva affatto come un semi-non-vedente ma sempre con sicurezza. Ogni mattina prendeva il suo treno per Rovigo. E, soprattutto, non si lamentava mai.
Alla fine, per uno straordinario colpo di fortuna, un suo decrepito ex-professore gli segnalò un oscuro e anziano oculista, che era sempre vissuto in Africa. Costui tentò l’operazione e mio padre tornò a vedere.
Ebbene, pochi anni prima di riacquistare la vista, cosa che sembrava un miracolo impossibile, mio padre fece due viaggi senza la famiglia: uno a Palermo (andava pazzo per l’autore de Il gattopardo) e uno a Parigi (con un suo vecchio amico), dove si divertì moltissimo.
Ciò go da vedare Le Folì Bergèr prima de deventare orbo del tuto (“Devo vedere Les Folies Bergères prima di diventare cieco del tutto”), disse per far arrabbiare mia madre, che infatti la prese molto male, ma, ovviamente visitò tutta quanta la ville lumière.
Ma torniamo ai suoi viaggi con la famiglia.
Nella prima metà degli anni sessanta andammo in Puglia e Basilicata, che allora erano terre assai esotiche, e facemmo inoltre un viaggio meraviglioso, durato l’intero mese di settembre, in cui percorremmo in lungo e largo tutta la Spagna.
Nel 1964 in Spagna di italiani ne andavano ancora pochissimi e quei pochi solo sulla Costa Brava, e in piena estate.
Eravamo a bordo di una Fiat 850 in tre: mio padre, instancabile al volante, mia madre davanti e io dietro. E quasi mai da sola, perché lui prendeva a bordo qualsiasi tipo di autostoppisti: dal militare in licenza a delle ragazze che andavano a ballare in un paese vicino, al contadino che lavorava nei campi.
Non aveva nessuna diffidenza nei confronti degli estranei.
Mi resteranno per sempre nella memoria le distanze sconfinate delle mesetas bruciate dal sole, dove non si vedevano altre vetture per ore e ore. I centri abitati erano molto distanti l’uno dall’altro, sicché il segnale luminoso della riserva di carburante lampeggiava spesso.
Mio padre, totalmente impegnato nella guida, aveva deciso che l’addetta alle publics relations fossi io:
Ciò, pico(e)a, domandaghe dove xé el prosimo distributor dea benzina… dove se magna ben. (“Piccola, chiedigli – all’autostoppista di turno – dov’è il prossimo distributore della benzina… dove possiamo trovare un buon ristorante etc.”).
Avevo quattordici anni, ero timidissima e non ero ancora stata all’estero e se, attraversando la Provenza, me l’ero cavata col mio francese, allora solo scolastico, in Spagna avevo molto pudore ad esprimermi con gli autoctoni, detestando farlo in uno spagnolo maccheronico.
Lo feci presente a mio padre che tagliò corto:
Eh, cossa sarà?! Varda questo! (“Cosa vuoi che sia?! Guarda questo!”).
E lo disse porgendomi un piccolo prontuario, che aveva preso in un distributore della BP, dove c’erano alcune frasi essenziali, in tre-quattro lingue, solo per la stretta sopravvivenza.
Ben presto, ci presi gusto: imparai la pronuncia ispanica, che mi stava molto simpatica, e un sacco di vocaboli e, così, facevo lunghe conversazioni con qualsiasi tipo di persone mio padre caricasse nel sedile posteriore.
Al ristorante mio padre era sempre di ottimo umore e, se non riusciva bene a capire in che cosa consistesse un piatto scritto nel menù, non faceva domande e lo ordinava lo stesso, perché era molto curioso. Se arrivava qualcosa di davvero sorprendente, scoppiava a ridere e lo divorava allegramente.
Mi spiegava che era stupido rimpiangere la cucina italiana, ma che bisognava adattarsi al gusto del paese, senza tante fisime.
Mia madre, che era delicatissima di stomaco era sempre in crisi mentre io, che pure non ho mai avuto una digestione facile, non mi tiravo mai indietro.
Se un cameriere gli stava simpatico, mio padre lasciava mance faraoniche, cosa che del resto faceva anche in Italia.
L’aggettivo con cui potrei definirlo è “magnifico”, un aggettivo che lui amava molto nell’accezione di “splendido”, in quanto “munifico”.
No’ posso védare i peociósi! (“Non sopporto i tirchi!”), mi diceva sempre.
Anche, adesso, a distanza di molti decenni, delle volte, quando sono lì lì per lasciare una mancia non tanto generosa, me lo vedo davanti agli occhi che mi guarda con commiserazione, scuotendo la testa.
Allora mi vergogno e correggo subito il tiro.
14. Mio padre e il vino.
Nei viaggi con mio padre, nell’infanzia e durante la pre-adolescenza, c’era una cosa che non potevo fare assieme a lui: potevo sì sperimentare cibi sfiziosi, ma non potevo ancora bere un buon bicchiere.
Mio padre aveva deciso che l’età in cui avrei cominciato a familiarizzarmi col vino era sedici anni.
Da sempre ero piuttosto disappetente o, meglio, lo ero solo nei riguardi della cucina di mia madre. Lei era troppo salutista e non ci ammanniva che cibi lessi o ai ferri, esclusivamente conditi a crudo. Persino il pepe – non parliamo poi del peperoncino – era bandito dalla tavola e non si mangiavano mai salumi, ad eccezione del prosciutto crudo.
I fritti non esistevano. Stendo un velo pietoso sui suoi dolci che contenevano un uovo in tutto e pochissimo burro, la cioccolata poi era proibitissima.
Mio padre, che sapeva che mia madre non tollerava assolutamente critiche sulle sue prestazioni di cuoca, evitava i conflitti e si sfogava mangiando, al banco e specie di mattina, polpette o sponcetti vari in qualche piccola trattoria. Questo non intaccava minimamente il suo appetito che restava formidabile.
Io, invece, che tali sfoghi non potevo ancora avere, sottoposta a quel deprimente regime, non mandavo giù quasi niente: spesso mi alzavo da tavola, fingevo di avere un bisogno impellente, andavo in bagno e sputavo il boccone che stavo masticando da un bel po’, specie se era di carne.
Questo fin dall’infanzia, sicché, durante l’estate venivo spesso spedita dai miei zii a Roma dove, in compagnia dei miei cugini, mangiavo senza problemi e di gusto.
Sugli Appennini poi mi nutrivo di nascosto fuori dai pasti, foraggiata dalle mie prozie che mi ammannivano cibi a base di farina di castagna, frittelle varie, croccanti di noci, ma anche gustosi crostini di pane toscano, farcito con le interiora tritate delle galline, ridotte ad un rustico paté. Ecco perché non ho mai capito tutto questo amore per la banale Nutella.
Ovviamente, a cena discussioni a non finire con mia madre, perché spiluccavo appena quello che c’era nel piatto.
Insomma, a sedici anni ero magrissima, specie nei mesi in cui frequentavo le scuole.
Mio padre optò allora per una terapia d’urto. Mi propose di bere mezzo bicchiere di vino prima di cominciare il pasto, come se fosse una sorta di medicina, convinto che l’appetito ne sarebbe stato stimolato.
E aveva ragione.
Dai tempi di Udine, per lui il vino per eccellenza non era veneto bensì friulano. Se lo faceva arrivare, ricordo, da Casarsa della Delizia in damigiane, che poi lui imbottigliava.
Il suo preferito era il Tocai – molto più buono di quello di adesso – ma mio padre mi favoleggiava di quanto gli piacesse anche il Reisling.
Prediligeva, insomma, i vini bianchi parecchio secchi e fermi.
Mi me piase più de tuto el vin da pésse (“Mi piace soprattutto il vino per accompagnare il pesce”), era solito dire.
Ebbi qualche resistenza a mandar giù quel primo mezzo bicchiere di Tocai, che appariva tosto e troppo dry per il palato di una principiante di Bacco.
Mio padre fu inflessibile:
Para zò! Te vedarè che tra ‘na setimana me tocarà misurarte i goti. (“Buttalo giù! Vedrai che tra una settimana mi toccherà misurarti i bicchieri”), ossia stare attento che tu non ne beva troppo.
E fu proprio così.
I pasti in famiglia divennero più allegri e non badavo più a quanto poco appetitosi fossero i piatti cucinati da mia madre.
Fin dall’inizio, lui mi aveva preso da parte e mi aveva ammonito con un tono che non ammetteva repliche:
Che no’ senta mai che te piase el vin da done! (“Che non venga a sapere che ti piace il vino da donne!”), alludeva al vino dolce, di scarsa gradazione, magari qualche scadente spumante. E aggiungeva perentorio:
E che no’ te senta mai dire: “Ciò, me gira la testa!” (“E che non ti senta mai dire: ‘Mi gira la testa!’ ”). E qui assumeva un tono in falsetto da donnetta astemia, una che non tiene nemmeno un bicchiere di vino, emettendo una vocina oltremodo ridicola.
Parché se te parli cussì, no’ te sì gnanca me fio(e)a! (“Perché se parli così, non sei nemmeno degna di essere mia figlia!”), concludeva in maniera definitiva.
Mi affrettavo a rassicurarlo che mi sarei abituata presto al vino che piaceva a lui.
E non lo delusi di sicuro! Tanto che mio padre, maliziosamente, osservava:
Desso te piaze el chèno, vèro? Eo savevo ch’ea finiva cussì! Ocio a no’ diventare sampagnina! (“Adesso, ti piace il vino, eh? Lo sapevo che finiva così! Sta attenta a non diventare una a cui piace troppo il vino”).
Quanto a lui, beveva molto raramente acqua. Glielo vidi fare sempre e solo in montagna, possibilmente abbeverandosi a fresche fontane. Beveva molto caffè e non disdegnava il the, per cui dei liquidi non alcolici ne ingeriva.
Quando gli facevo notare che lui l’acqua l’usava solo per lavarsi, lui mi rispondeva puntualmente con un vecchio proverbio veneto:
L’acqua marsisse i pai e fa i ómani zai! (“L’acqua marcisce i pali e rende gli uomini gialli”), ossia un colorito poco sano.
Le lezioni di mio padre in tema enologico proseguirono precise e molto chiare. Allora, non esistevano ancora le enoteche sicché non era facile fornire i fondamenti di come abbinare i vari cibi ai vini più adatti.
Provvidenziali erano le cassette di vini pregiati che mio padre, all’epoca, riceveva in dono a Natale. Ad esempio, se gli regalavano dei vini piemontesi, lui me ne spiegava le differenti caratteristiche e l’impiego ottimale a tavola.
All’epoca, una ragazza che sapesse che il Dolcetto non è affatto un vino soave, vi assicuro, era una mosca bianca.
Quando dagli Appennini ci si spingeva in Toscana, o in generale nel Centro Italia, mi spiegava cosa non pretendere, ossia del vino bianco, laddove dominava il Chianti.
Ma se gli capitava di poter ordinare una bottiglia di buon Orvieto o di ottimo Est Est Est (tutti vini oramai sviliti dai supermercati), ne era molto contento.
Dopo gli anni dell’università, quando aprirono le prime enoteche, non più sotto la guida di mio padre, sperimentai moltissimi tipi di vini, di regioni e di paesi diversi ma le nuove conoscenze potevano attecchire e svilupparsi con profitto solo perché le mie basi erano già solide.
Inoltre, l’essere stata iniziata da un conoscitore m’impedì di diventare un’alcolizzata, il che in una regione come il Veneto non è affatto scontato.
Insomma, ancora adesso, se a mio giudizio, un vino è scadente, non lo bevo. Magari ci intingo appena le labbra per non offendere chi mi ospita. Oppure lo butto via di nascosto.
Se invece è buono…
Mio padre aveva una tenuta leggendaria: poteva bere gagliardamente ma non si ubriacava mai. Al massimo diventava più allegro, ma mai era brillo in maniera sgradevole. La voce e le gambe gli rimanevano ferme, al massimo gli brillavano gli occhi in maniera birichina. Ma non c’era pericolo che divenisse troppo loquace o sboccato, né meno che meno che alzasse la voce.
Anche questa era una caratteristica che molto gli invidiavo.
Il famoso viaggio in Spagna si concluse con uno spettacolare incidente, in cui la povera 850, nuova di zecca, finì poi rottamata.
Due camion si sorpassarono in una strada stretta e tutta curve e mio padre, che guidava sempre con prudenza e a velocità moderata, per non farsi investire da quei due mastodonti, si spostò sul bordo della caretera, che era stretto e in terra battuta nonché costellato di grandi sassi acuminati. Uno di questi tranciò di netto il tirante dello sterzo e così volammo di sotto, ossia in un oliveto a terrazze. Ne facemmo tre e ci fermammo a mezzo metro da un ulivo secolare, che ci sarebbe stato letale ma, per fortuna, una delle ruote si accartocciò e la vettura si bloccò.
Durante tutto il tempo che durò quella spettacolare uscita di strada, in cui vidi distintamente, come nei film, l’orizzonte spostarsi di netto più d’una volta ed ero convinta di morire, mio padre si mantenne saldo al volante, anche se oramai inservibile, mostrando un sangue freddo invidiabile.
Mia madre lanciò una serie di urletti, io mi morsicai le labbra a sangue perché gli strilli non mi piacciono, nemmeno in situazioni estreme.
Quando la macchina finalmente si fermò, mio padre tolse con calma la chiavetta, spegnendo così il motore, e ci domandò tranquillo:
Stè bén? (“State bene?”).
Eravamo tutti e tre miracolosamente illesi, eccezion fatta per qualche livido e qualche piccolo bernoccolo… non esistevano ancora le cinture di sicurezza.
I camionisti scellerati nemmeno si fermarono e fummo soccorsi da una famiglia di tedeschi, convintissimi di trovarci sanguinanti, se non peggio.
Costoro, che indossavano dei nefandi ed indimenticabili pantaloncini corti, si precipitarono agilmente giù per l’uliveto, i due genitori in testa e due figlioletti dietro, in perfetta fila indiana. L’ultimo reggeva una valigetta del pronto soccorso, con tanto di croce scarlatta.
Sarà stato il calo di tensione, fatto sta che mia madre ed io scoppiammo a ridere.
Mio padre, invece, esclamò ammirato:
Varda sti tedeschi, che organizassión! (“Guarda questi tedeschi, come sono organizzati!”).
Ma perché racconto codesta storiella? Semplicemente perché, dopo che fummo recuperati dal carro attrezzi, finimmo in un paesino dotato di varie officine meccaniche, zeppe di automobili ammaccatissime.
Gli incidenti erano, perciò, assai frequenti in quel micidiale tratto di strada e costituivano il perno dell’economia locale.
Mio padre propose di rifocillarci e di dormire in una modesta locanda.
Là, lo sentii dire a mia madre:
Sémo vivi par sbajo: Ana, me despiase, ma sta sèra me imbriago! (“Siamo vivi per sbaglio: Anna, mi dispiace ma questa sera mi ubriaco”).
Mia madre, che era praticamente astemia, quella volta, non ebbe nulla da obiettare.
A tavola, mio padre scolò più di una bottiglia, ma non fece né disse nulla di disdicevole, era semplicemente parecchio allegro e alzava spesso il calice con un sorriso raggiante.
Uno dei rimpianti che ho è di non aver potuto brindare con lui quella sera.
15. Mio padre e l’arte.
Durante i viaggi più lunghi e così pure quelli lampo, specie in Toscana, mio padre non si limitava a godere delle specialità eno-gastronomiche dei luoghi visitati, perché un altro era lo scopo principale di quegli spostamenti.
Amava moltissimo visitare chiese, monumenti e talora musei.
Il padre di mio padre, mio nonno Giovanni aveva, in quel di Abano Terme, una piccola impresa che decorava e affrescava l’interno di ville venete gentilizie.
Quel mio nonno, che rimpiango parecchio di non aver potuto conoscere, si era fermato alle elementari ed era un autodidatta che amava sinceramente la pittura e sapeva dipingere. Ad Abano mio nonno era considerato “un artista”.
Esiste ancora, a casa di mio fratello, un suo splendido autoritratto ad olio.
Un gran bell’uomo, mio nonno Giovanni, molto simile a mio padre, coi baffi ma senza il pizzetto.
Mio padre mi raccontava che suo padre, ogni anno, portava i suoi dipendenti, che erano circa una decina, in “gita sociale” a Venezia e faceva loro visitare le Gallerie dell’Accademia, Palazzo Ducale e il Museo Correr. Ovviamente tale trasferta era a spese di mio nonno.
Io trovo questo tentativo di dirozzare le maestranze campagnole lodevole oltre che assai commovente.
Mio padre non sapeva dipingere, se non i mobili e le parteti e disegnava solo le piante delle case, ma nondimeno era appassionatissimo di pittura, soprattutto toscana, del quattrocento in primis.
Ricordo una visita al Museo di San Marco a Firenze e di come lui si aggirasse rapito nelle varie cellette affrescate da Beato Angelico raccontandomi, tra l’altro, le vicende dei Medici e di Savonarola. Questo avvenne quando ero già grandicella ma facevo ancora i primissimi anni delle elementari, quando mi condusse a Firenze per la prima volta.
Mi accompagnò subito in Piazza della Signoria dove rimasi oltremodo impressionata dalla Loggia dei Lanzi, in particolare dal Ratto delle Sabine di Giambologna e, appena di lato, dall’elegantissimo Perseo di Cellini.
Ed ero sempre una bimbetta quando mi fece visitare gli Uffizi portandomi direttamente al cospetto della Primavera del Botticelli.
Mio padre aveva una tecnica tutta sua nel guidarmi in un museo: preferiva una visita breve, concentrata su pochi quadri per volta. Per farmi ammirare altri capolavori, contava su una visita successiva. Cosa che poteva avvenire benissimo ripetutamente nel corso della stessa estate perché, allora, negli anni cinquanta e sessanta, Firenze era raggiungibile in treno, dalla mia casa appennica, più facilmente e in meno tempo che adesso.
Ricordo che una volta, al Pitti, ad un certo punto, dopo che avevamo ammirato i quadri di Tiziano, mio padre sentenziò:
Par ancó basta cussì: fóra! (“Per oggi basta così: fuori!”).
Avevamo visto solo una parte del museo e io ero recalcitrante ad interrompere la visita, ma lui non volle sentire ragioni, dichiarando che, per quel giorno, era meglio per me scorrazzare per i giardini dei Boboli, che poi mi piacquero moltissimo.
Il fatto è che mio padre, uomo accorto e saggio, temeva che io finissi per associare la visita ad un museo ad una faticata sgradevole e vessatoria, il che avrebbe compromesso per sempre il mio approccio all’arte.
E se io, ad un certo punto, avessi mostrato fastidio o indifferenza per l’arte, per lui sarebbe stato un immane dolore.
Me ne rendevo benissimo conto, ma vi giuro, che mai trovai noioso visitare una chiesa o un palazzo: era sempre molto divertente farlo assieme a lui.
Con la strategia delle piccole dosi, a poco a poco, all’epoca delle medie, conoscevo già svariati tesori di Firenze, dalle porte del Battistero del Duomo al campanile di Giotto, dal Salone dei Cinquecento alla Cappella Brancacci (dove mio padre m’insegnava a distinguere il tratto di Masaccio e Masolino da quello, più tardo, di Filippino Lippi), da Orsammichele a Santa Croce.
Amava molto la pittura ma era pure affascinato dalla scultura e dall’architettura. Mi faceva ammirare le possenti Tombe Medicee o il David di Michelangelo ma aveva un debole anche per i delicati bassorilievi di Luca della Robbia. E, perciò, molto presto m’innamorai degli sfondi azzurri delle ceramiche invetriate.
Mi portava poi davanti a Palazzo Strozzi o a Palazzo Medici Ricciardi e là m’illustrava il susseguirsi dei tre tipi di bugnato e lo sentivo esclamare:
Cossa che ea me piaze mi la piera serena! (“Quanto mi piace la pietra serena!”).
Anche i vecchi pavimenti di cotto lo mandavano in visibilio.
Mi sono soffermata a lungo su Firenze perché fu il mio battesimo per la storia dell’arte ma con mio padre spesso ci si spingeva anche più lontano, ad esempio, a San Gimignano, ad Urbino, a Spoleto ad Orvieto.
Predilegeva anche Assisi e Gubbio e tante altre piccole località umbre.
Inoltre, andava pazzo per la costiera amalfitana e, in particolare per Ravello. Non vi posso dire il suo entusiasmo per villa Rufolo e per lo stile arabo-normanno.
Cossa me serviria ‘vere un fià più de schèi? Tanto xé qua che me piasaría stare! (“Cosa mi servirebbe avere un p0’ di più soldi? Tanto è qui che vorrei abitare”).
Niente vie di mezzo, perciò. E qui tornava in campo una sua felice risorsa: la fantasia.
Amava anche i giardini all’italiana e non trascurava nemmeno gli scavi archeologici: con lui visitai Paestum, in un’epoca arcaica, quando ancora le pecore pascolavano tra i templi. E così pure conobbi Pompei, quando non era affatto affollata.
Concludendo, i gusti artistici di mio padre erano ottimi ma molto tradizionali – i suoi amori in pittura, ad esempio, non andavano oltre la fine del ‘700 – e sarebbe stato molto limitante per me se poi non mi fossi interessata all’arte contemporanea, che, invece, dal liceo in avanti, cominciò ad attirarmi moltissimo.
Successe come con il vino: mio padre mi diede solide basi su cui ampliare in seguito le mie conoscenze.
16. Mio padre e la poesia.
Tutto quello che ho raccontato di mio padre sarebbe assolutamente insufficiente se non vi parlassi di una sua particolarità, a mio avviso, la più caratterizzante di tutte: l’arte di modulare la voce soprattutto quando leggeva o declamava poesie o prose letterarie.
Lui che, quasi sempre non si esprimeva se non in dialetto, aveva, se decideva di servirsene, una voce impostatissima da attore mancato: uno dei suoi tanti aspetti paradossali.
Perfetta era la sua dizione, inappuntabili le sue vocali, i suoi dittonghi e così pure tutte le singole sillabe delle parole, mai aperte o chiuse a casaccio, ma secondo regole ben precise: quelle giuste.
Sembrava che avesse frequentato l’accademia d’arte drammatica.
Era stato inizialmente avvantaggiato dall’avere una madre toscana, la quale però, abitando in Veneto, stava, negli anni, intorbidando la purezza della sua parlata.
Da una testimonianza della sorella preferita di mio padre, Gemma, ho scoperto, che sin da bambino mio padre era solito leggere a voce alta ai familiari poesie e prose, servendosi inizialmente dei libri di scuola.
In casa, del resto, libri ce n’erano pochini, anche se mio nonno Giovanni recuperava tutto quello che poteva nelle soffitte o nelle stanze dei palazzi di nobili decaduti, indegni della cultura degli avi. Capitava, infatti, che costoro, cui mio nonno riaffrescava la casa, volessero disfarsi di vecchi libri e chiedessero al “pittore” di buttarli direttamente nelle immondizie. Mio nonno, invece, li portava a suo figlio.
Accadde così che il piccolo Mario si trovò a maneggiare, già a meno di dieci anni, consunte edizioni settecentesche di Metastasio e di altri poeti italiani, anche quelli annoverati tra i cosiddetti “minori” – categoria che per mio padre, da persona intelligente qual era, non ebbe mai nessuna rilevanza.
Ricordo, ad esempio, la sua grande passione per Il Bacco in Toscana di Francesco Redi o per le canzoni di Lorenzo il Magnifico.
Mio padre mi raccontò che una volta, al ginnasio, gli capitò in classe un supplente toscano che declamò mirabilmente Pascoli e Carducci, al che, mio babbo fece subito tesoro della perfetta dizione di quell’occasionale insegnante.
In prigionia poi mio padre ebbe come compagni alcuni futuri attori di teatro che, probabilmente, contribuirono vieppiù ad affinare la sua arte di porgere.
Il tutto era accompagnato da una memoria prodigiosa, che gli derivava solo in minima parte dalle consuetudini scolastiche dell’epoca, perché era lui che, fin da bambino, si chiudeva da qualche parte per ore e imparava a memoria qualsiasi testo gli piacesse, ben al di là di quello che dovesse fare come compito per casa.
Nei campi d’internamento libri non ce n’erano e lui era molto apprezzato dai suoi compagni perché sapeva a memoria interi canti di Dante, ottave su ottave di Ariosto e tantissimi altri versi.
Un posto a parte aveva l’Alcyone di D’Annunzio.
Mia madre confessò di essersi innamorata di mio padre quando, ancor prima che si fidanzassero, lui le recitò di fila alcune poesie di quella immaginifica raccolta.
Negli anni sessanta, a Gorizia, capitò a mio padre di vedere un film di Truffaut e ne fu entusiasta. Era Fahrenaith 451 (1966). Ne capii solo in seguito – quando lessi il famoso romanzo di Bradbury – il motivo: mio padre, tra quei prigionieri che illetterati certo non erano, aveva già giocato il prezioso ruolo di uomo-libro.
Sono impotente a comunicarvi lo charme della sua voce, dal timbro scuro e basso, tuttavia non rude ma con un che di carezzevole, dove ogni parola veniva scandita con ritmica chiarezza e insieme con malia. Non posso nemmeno lontanamente farvi immaginare l’arte consumata delle pause orchestrate da quella voce. Insomma, ascoltando mio padre, si scatenava quello che Dante, nel sonetto Guido vorrei – lirica amatissima da mio padre – definisce “incantamento”.
Fin da piccolissima, fui soggiogata delle sue declamazioni: gliene chiedevo ancora e ancora, senza mai annoiarmi.
Anche in questo caso, allo stesso modo che con la pittura, mio padre fu abile e accorto nel non farmi avere un approccio vessatorio con la poesia. Ricordo che inizialmente scelse solo componimenti che soprattutto mi divertissero.
Mi proponeva le simpatiche filastrocche di Giuseppe Giusti oppure mi recitava le scherzose rime di Trilussa; e lo faceva con un accento romanesco impeccabile, risalente agli anni della Cecchignola e che io apprezzavo molto grazie ai miei precoci soggiorni nella Capitale.
Attraverso quei versi faceti, ma insieme sferzanti, venivo introdotta pian piano nel regno della Poesia, dove avrei presto incontrato testi ben più impegnativi.
Ai miei tempi, come a quelli di mio padre del resto, Pascoli e Carducci la facevano da padrone nei programmi scolastici delle elementari e delle medie. Ma, recitati da mio padre, quei poeti “ufficiali” perdevano ogni banalità e ogni loro poesia diventava una storia appassionante.
Fino alle superiori, non mi capitò mai di sentire in classe una poesia che già non conoscessi da tempo.
Ero ancora una bambina quando lui mi recitava i sonetti di Dante, ma anche Cavalcanti e Leopardi.
Non trascurava nemmeno la prosa trecentesca, per cui aveva una grande passione.
Mi leggeva persino Boccaccio. Ovviamente, lasciava perdere le novelle più lascive e si concentrava solo su quelle che mi avrebbero fatto ridere o stupire.
Mi lesse più volte Andreuccio da Perugia o quella in cui si narra della trovata del cuoco Chichibìo. E, senza farsi gran riguardo per quello che m’insegnavano sui Sacramenti alle lezioni di Catechismo, mi leggeva con grande gusto la falsa confessione di quello spudorato furfante che è Ser Cepparello, divenuto poi San Ciappelletto.
Ciò, ghe ne gaveva fate massa e chi lo gavaría perdonà? Tanto vaeva finire ea so vita co’ un capolavoro: queo nol géra un busiáro: el gera un genio! (“Ne aveva fatte troppe, come avrebbe potuto ottenere l’assoluzione? Tanto valeva finire con un capolavoro: quello non era un bugliardo: era un genio!”).
E ne ridevamo assieme a crepapelle.
Mi leggeva, altresì, I Fioretti di San Francesco, non solo perché aveva gran simpatia per il Poverello di Assisi, ma soprattutto perché era innamorato dell’idioma in cui venivano narrate le sue gesta.
Va detto che, essendo io ancora implume, avevo qualche problema con quella lingua così arcaica e talvolta protestavo che non capivo certi termini e avrei preteso che mio padre me li spiegasse uno per uno. E, allora lui, passando dal suo perfetto italiano attoriale al dialetto, tagliava corto:
Cossa goi da spiegarte, pico(e)a? Se te sté ‘tenta, te vedarè che te capissi tuto: no’ ghe xé paroe difissii! (“Cosa devo spiegarti, piccola? Se stai attenta, vedrai che capisci tutto: non ci sono parole difficili!”).
E, incredibilmente, avveniva il miracolo: la sua recitazione era così espressiva e suadente che io finivo per comprendere anche i lemmi più rari, anche le forme grammaticali più obsolete.
Si abusa dell’espressione “pendere dalle labbra”, ebbene, io vivevo per sentire quella morbida, e insieme possente, voce uscire dalle sue labbra. Quella voce recitante di cui, ancora adesso, muoio di nostalgia.
17. Mio padre e la scrittura.
Quando, da bambina, rovistai in quel famoso cassetto e scoprii in quello strano cuscino le lettere d’amore che mio padre scriveva a mia madre, da fidanzato, trovai anche dell’altro.
Mi capitò in mano una missiva di Diego Valeri – poeta e intellettuale allora piuttosto conosciuto e ora dimenticato – in cui costui diceva di aver letto una raccolta inedita di poesie, che mio padre gli aveva inviato e di averne apprezzato soprattutto una, di cui, purtroppo, non ricordo il titolo. La lettera si concludeva addirittura con un incoraggiamento alla pubblicazione.
Mi precipitai da mio padre e gli chiesi come fosse andata a finire: se aveva poi pubblicato un libro di poesie e, se sì, dove fosse finito.
Si seccò alquanto e disse che, dopo quella lettera – che lui mi strappò di mano e che fece subito sparire – aveva distrutto tutte le sue poesie, tanto più che a pubblicarle non ci pensava proprio.
Alle mie vivaci proteste, rispose che le sue poesie non valevano ‘na cica (“nulla”) e che erano: dee stupidae (“delle stupidaggini”).
Ci rimasi malissimo.
Dunque, avevo la prova provata che la poesia occupava davvero un grande posto nella vita di mio padre, non solo facendone uno squisito dicitore, ma ora sapevo che lui aveva accarezzato in gioventù il desiderio di diventare, a sua volta, poeta.
Tale istanza, però, era tramontata presto anche perché contro di lui s’era ritorta quella forte tendenza, che aveva nei confronti degli altri.
Ovvero, se mio padre era fieramente critico nei riguardi di chicchessia, nondimeno era ferocemente autocritico.
Quanto alla poesia, essa scorreva nelle vene della famiglia o, meglio, in una sua parte. Mio padre, come già vi dissi, aveva tre sorelle, la più grande e la più piccola erano matematiche e una terza, quella di mezzo, Gemma, quella che più gli era affine, era destinata a diventare una poetessa apprezzata, così come lo sarebbe divenuta in seguito sua figlia: mia cugina Lucia.
Tra parentesi, Gemma, all’epoca dell’università, aveva avuto una brevissima ma intensa carriera di attrice, recitando a teatro tragedie greche.
E quando parlo di mio padre come di un “attore mancato” ho ben presente che pure lui avrebbe avuto in pieno il talento per recitare, ma in questo, secondo me, era stato frenato dalla sua grande timidezza.
Mio padre era morto da qualche anno, quando, in un’affollatissima bettola davanti a casa mia, una sera, feci uno strano incontro.
Un cliente, che non avevo mai visto e che non avrei più rivisto, probabilmente dopo essersi informato su chi io fossi, mi si rivolse chiamandomi: “Ciao, sorellina!”.
Basita, gli domandai la ragione di tale appellativo.
Al che, lui mi svelò che era figlio di quella famosa ragazza, amica di mia zia Gemma, di cui mio padre si era perdutamente innamorato prima della guerra.
Ma il bello sta in una parte della storia che io ancora ignoravo del tutto.
Era accaduto che il padre del mio mancato “fratellino” fosse stato, per qualche tempo compagno di prigionia del mio di padre. Ebbene, a costui mio padre aveva raccontato del rifiuto subito da una certa fanciulla.
Mio padre era di carattere molto riservato e forse si aprì con quel coetaneo perché erano entrambi originari della stessa città – sono soltanto mie supposizioni.
Ma non si trattò di semplici confidenze: mio padre recitò a memoria fior di poesie, che lui aveva composto per la bella sdegnosa e che ricordava a memoria.
Costei, peraltro, era dotata di un nome egregiamente letterario: si chiamava Laura.
Insomma, mio padre tanto decantò con parole poeticamente fiorite la beltà e le grazie di questa Laura, che il suo confidente s’innamorò di lei, prima ancora di conoscerla.
Tutto questo ha un’aria di famiglia con una poesia di Carducci che narra di un illustre poeta provenzale: Giufredo Rudell, che s’innamora d’una leggiadra contessa attraverso le lodi che sente fare di lei e riesce a vederla e a baciarla solo mentre sta per morire.
Inutile che vi dica che mio padre mi recitava spesso questa poesia – che vi consiglio caldamente di leggere – e con grande trasporto.
Quanto al futuro padre del mio informatore, costui, tornato dalla prigionia, riuscì a conoscere questa famosa Laura, le fece una corte spietata e, nonostante fosse piuttosto bruttino, riuscì a sposarla.
Evidentemente, l’ultima cosa che mio padre avrebbe desiderato.
Tale disastroso epilogo della sua disavventura amorosa – immaginate il reiterato e definitivo smacco! – deve avergli bruciato vieppiù e, ovviamente, non me ne fece mai parola.
Chissà se nelle poesie inviate a Diego Valeri, figuravano liriche dedicate a questa “novella” Laura… non lo si saprà mai…
Ecco, vi ho detto tutto quello che ho potuto scoprire circa la sommersa carriera poetica di mio padre.
Ora che ci rifletto, non vidi mai mio padre scrivere alcun testo: non solo non teneva nessun tipo di diario, non annotava, neppur brevemente, le sue impressioni di viaggio, non scriveva nemmeno più lettere. È come se il canale della scrittura si fosse in lui precocemente disseccato.
Di contro, lui ci teneva moltissimo che io sapessi scrivere con brio e proprietà e dava per scontato che, da piccola, fossi la più brava della classe nei temi. Cosa che, con tutte le declamazioni paterne che mi ero bevuta fin dalla più tenera infanzia, mi riusciva molto facile e naturale.
Quando cominciai ad interessarmi seriamente alla filosofia, presi a desiderare di scrivere qualcosa di originale in quel campo.
A mio padre raccontavo dettagliatamente lo schema di ogni libro o saggio che stavo progettando, se ne discuteva animatamente assieme e, una volta che avevo finito di scrivere, era a lui per primo che consegnavo il frutto delle mie fatiche.
E qui cominciavano i dolori.
Mio padre era molto contento che m’interessassi, se pure in maniera anticonvenzionale, al mondo greco e latino ma era critico su come talvolta sostenevo le mie tesi.
In particolare, detestava la scrittura saggistica che fa sì che i filosofi scrivano solo per altri filosofi e, di conseguenza, non sopportava che mi servissi di termini specialistici che potevano risultare incomprensibili per chi filosofo non era.
Trovava anche da ridire su come io conducevo certe argomentazioni: se, ad esempio, lo facevo in maniera troppo criptica o eccessivamente allusiva.
Mi rileggeva la frase incriminata – ne trovava varie – e mi chiedeva lumi, io gli spiegavo dove volessi andare a parare e lui, dopo aver seguito c0n attenzione il filo del ragionamento, sbottava:
Però qua no’ se capisse un bao e invesse se ga da capire! (“Però qua non si capisce nulla e, invece, si deve poter comprendere!”).
Conclusione, io riscrivevo quella frase, o quel giro di frasi, finché lui soddisfatto non mi diceva:
Eco, ‘desso ghe semo! ‘Desso xé ciaro! (“Ecco, ora ci siamo! Adesso è chiaro!”).
E aveva perfettamente ragione! Fu sommamente istruttivo per me emanciparmi, quando scrivevo, dal gergo degli “addetti ai lavori” e da quell’argomentare troppo oscuro con cui i filosofi spesso si pavoneggiano.
Se, da una parte, nella scrittura voleva chiarezza, d’altra parte, aveva un debole per l’aggettivazione suntuosa, sicché per lui non era un problema se certi vocaboli potevano suonare preziosi:
Ciò, che i lèza D’Anunsio! Che ghe fa so(e)o che bén! (“Che leggano D’Annunzio! Che fa loro solo bene!”).
Per il discorso parlato mio padre, però, aveva un altro metro perché era sempre stato lui ad insegnarmi che, quando si parla, magari con chi non ha avuto una buona istruzione, bisogna astenersi da fare sfoggio della propria cultura e scegliere sempre parole comprensibili da tutti.
Chi non lo faceva era subito ritenuto da lui un gran boaro, pien de spusse. E qui andiamo sul semi-intraducibile, se non ricorrendo ad espressioni gergali: “un grande cafone, che se la tira”, ovvero uno con la puzza sotto il naso.
E sottointesa era l’allusione ad un gustoso proverbio veneto, che mio padre ripeteva spesso:
Vilan che monta in scano o ch’el spussa o ch’el fa dano (“Zotico che sale un gradino sociale o si dà delle arie o è dannoso”).
18. Mio padre e la lettura.
Voglio dire ancora una cosetta su mio padre lettore che non riguarda il fatto che lui aveva spesso un libro in mano e nemmeno le sue preferenze letterarie.
Del resto, i suoi gusti letterari, che erano alquanto tradizionali, molto presto mi stettero assai stretti e mi misi a leggere a rotta di collo autori che lui non mi aveva mai nemmeno lontanamente nominato.
Voglio, invece, ricordare un bizzarro fenomeno.
Se ci si avvicinava a mio padre immerso nella lettura, si udiva uno strano rumore, che lui emetteva a bocca chiusa. Era una specie di monotono ronzio. Non si trattava di un suono forte ma di una vibrazione sorda e continua.
Mi domandai spesso da cosa dipendesse e, scioccamente, non gliene chiesi mai ragione.
Forse lui voleva far sentire una sommessa eco di quello che sarebbe stata la sua lettura ad alta voce: forse non era non era capace di soffocare del tutto la sua arte declamatoria .
Questa potrebbe essere una spiegazione plausibile.
Compiuti i trent’anni, quando cominciai a progettare un libro sull’insorgere, e sul significato, della lettura silente e concepii quello che sarebbe diventato L’occhio del silenzio (libro che mio padre amò molto), non nego che il mio fu anche un omaggio a questo strano modo di leggere tra sé e sé che caratterizzava mio padre.
Forse in lui s’era conservata la memoria ancestrale di quello che era stato il rito “pubblico” della lettura ad alta voce prima che diventasse un fenomeno “privato”.
Forse…
19. Mio padre e i bambini.
Voglio affrontare una spiccatissima predilezione di mio padre: amava moltissimo i bambini e ne era da questi ricambiato con ardore.
Quello che vi sto per raccontare è solo in piccola parte desunto dai miei ricordi d’infanzia ed è, invece, costituito soprattutto da ciò che vidi fare da mio padre per i miei cuginetti, quelli nati ben dopo di me, che non erano pochi.
Già potete intuirlo, mio padre era bravissimo a inanellare spassose filastrocche e, soprattutto, a raccontare fiabe, assumendo voci assai diverse a seconda dei differenti personaggi, cui dava vita. Per lui era facilissimo passare dalla voce cavernosa di un orco a quella alquanto acuta di un’ingenua fanciulla, a quella flautata di una fata, a quella sentimentale di un principe o a quella malvagia di una strega sitibonda di vendetta.
Tutti effetti teatrali impossibili da rendere in questo povero testo scritto e che vi posso far solo immaginare alla lontana.
I bimbi, ovviamente, lo ascoltavano a bocca aperta.
Ma erano ancora più affascinati da altre performances di mio padre. Perché lui era capace di inscenare veri e propri spettacolini di magia.
Ad esempio, disseminava una stanza, dove i bambini non erano ancora entrati, di monete da dieci lire, occultandole sotto i vasi da fiori o sotto qualche soprammobile o tra le pagine di un libro.
I bimbi entravano poi nella stanza e mio padre faceva lestamente sparire una monetina, sempre del medesimo valore, con un fazzoletto, pronunciando funamboliche formule magiche e, da ultimo, invitava i bimbi a cercare l’oggetto scomparso dove, invece, era nascosto un suo omologo.
Sorvolo su tutti i giochi “magici” con le carte ma desidero evocare un “prodigio”, che ricordo con più nostalgia: quando faceva camminare un uovo sodo.
Si metteva con la faccia a livello della tavola, spalancava gli occhi e si rivolgeva ad un uovo, che caracollava sulla tovaglia, e gli parlava con voce insidiosamente suadente. Quando l’uovo arrivava a pochi centimetri dalla sua bocca, lui la spalancava, come il più tremendo degli orchi, e faceva l’atto di divorarlo emettendo una vociona assai minacciosa.
Al che, i bimbi, che erano tutti ancora piccini, urlavano felici. Ma, proprio in quel momento, sul più bello, l’uovo si sottraeva dalle fauci di mio babbo e se ne tornava bel bello indietro.
Il trucco c’era, eccome. E si basava sul fatto che mia madre faceva da aiutante al “mago”.
Ma come?
La tavola era coperta da una spessa tovaglia e sotto, completamente nascosto, c’era un anello matrimoniale con due cordicelle sottili, entrambe erano azionate, una da mia madre e l’altra da mio padre. I miei genitori, che stavano seduti di fronte, ai lati opposti del tavolo, avevano le mani nascoste dalle falde della tovaglia, che era molto abbondante e, a turno, o lasciavano lasco o tiravano pian piano il filo di loro competenza.
La mimica facciale di mio padre era così magnetica che a nessun bimbo veniva in mente di prestar attenzione a maneggi nascosti, che, così, restavano segreti.
Mi son spesso domandata perché lui amasse così tanto i pargoli.
Probabilmente perché li riteneva non ancora guastati da quei difetti che poi lui avrebbe detestato, una volta che i bimbi fossero cresciuti: lo scarso amore per la cultura e la cafonaggine.
20. Uno scontro con mio padre.
Sinora può sembrare che io abbia dato una visione troppo positiva di mio padre e che, per di più, voglia far credere che i miei rapporti con lui siano sempre stati un idillio.
Non è così.
I suoi appunti critici, anche se espressi col sorriso sulle labbra e con un tono di voce sempre civile, non erano per questo meno corrosivi e feroci.
Mi ci ero abituata e finivo per riderci sopra… quasi sempre…
Quando ero una ragazzina e avevo cominciato ad avere amici per la maggioranza dell’altro sesso, non ce n’era uno di cui lui non facesse la caricatura.
E gli bastava aver intravisto il malcapitato anche solo fuggevolmente. Inoltre, non amava il modo di atteggiarsi e, men che meno, di vestire dell’epoca, che era un’epoca di grande rottura con il passato.
Non trovava granché da ridire sulle chiome fluenti in voga, a patto che lo shampoo fosse frequente, ma non sopportava in nessun modo i pantaloni aderenti: le famose braghe ciuciarèe.
Quel capo di abbigliamento costituiva ai suoi occhi l’emblema di un modo di essere che lo irritava oltremodo.
Xé dée braghe da lollo, sentenziava.
Il termine lollo era un neologismo coniato da lui che costituiva la summa summarum di tutto quello che non sopportava in un ragazzo: la maleducazione, la scarsa cultura, il credersi intelligente e irresistibile quando, invece, non lo era, insomma, un voría ma no’ posso (“mi piacerebbe, ma la mia è solo una pretesa”).
Raccontai ai miei amici di questo appellativo con cui mio padre soleva dipingere gran parte dei cosiddetti “giovani moderni” e suscitai una tempesta di reazioni.
C’era chi riteneva mio padre uno strafottente, chi un intollerante, chi scoppiava a ridere, trovandolo spiritoso, ma il sentimento più diffuso era la speranza di non incontrarlo mai.
Cosa che non sarebbe stata poi così cruenta per loro: mio padre li avrebbe semplicemente ignorati.
L’appellativo lollo era così forte e perentorio – pur nella sua intraducibilità che, però, non aveva bisogno di traduzione – che seminava il panico: ognuno covava il terrore di essere lui quello cui mio padre potesse affibbiarlo.
Ci fu un mio amico, il più intelligente, il più raffinato e il più charmant di tutti, che prese a chiamare mio padre “l’anti-lollo”.
Con un padre come il mio, ça va sans dire, ero destinata a una vita sentimentale disastrosa, perché nessun uomo era in grado di reggere il suo confronto e gli unici che potevano essere alla sua altezza, beh, erano esattamente quelli di cui non era il caso che m’innamorassi.
Perché?
Perché erano gay.
Ora, mio padre non aveva nulla di sessualmente ambiguo ma sta di fatto che non ritrovai mai la costellazione delle sue qualità in un uomo cosiddetto “virile”, categoria che presi a detestare molto presto e che io reputavo piena zeppa di cafoni.
Ovviamente, anche colui che definì mio padre “l’anti-lollo”, era gay. E me ne innamorai perdutamente, ma questa è un’altra storia.
La storia del mio matrimonio è, invece, facile da raccontare e sin troppo prevedibile. Esasperata dalle continue angherie di mia madre, non vedevo l’ora di fuggire dalla vita familiare sicché finii per sposare, ancora troppo giovane, un semi-sconosciuto, apparentemente brillante ma che, invece, si rivelò un lollo a tutti gli effetti.
Fu un matrimonio disastroso ma piuttosto breve, che si concluse con una separazione e poi un divorzio.
Pratica che, in quell’epoca, era ancora nuova e rivoluzionaria e a cui ricorrevano solo quelli che si trovavano già in una situazione di sostanziale bigamia.
Insomma, un vero scandalo per una famiglia ipercattolica come la mia e motivo di grande riprovazione nonché di vergogna da parte di mia madre.
Per mio padre, che non mi disse mai una parola per dissuadermi da un matrimonio che, in cuor suo disapprovava, e che sapeva già non sarebbe durato molto, la questione era diversa. Non gli importava nulla della condanna sociale, ma sognava che io tornassi a casa.
Avendo poi compreso che non avevo nessunissima intenzione di farlo, mio padre si offrì di cercarmi un alloggio, impresa non facilissima perché avevo allora un assegno di studio, rinnovato di anno in anno, che era una vera miseria ed ero, altresì, irremovibile sul non farmi aiutare finanziariamente dai miei.
Al che, mio padre mi trovava degli appartamentini economici e modesti ma troppo vicini a casa dei miei.
Gli feci presente che, così, non avrei goduto di nessuna libertà di vedere chi mi pareva, con mia madre sempre pronta a controllarmi e magari ad indignarsi per la mia reputazione in pezzi.
E qui avvenne l’unico vero scontro che ebbi con mio padre.
Sì, perché lui mi disse tranquillamente che, dopo un matrimonio fallito alle spalle, ormai era chiaro che gli uomini non facevano per me e che, quindi, con i medesimi avevo chiuso, per cui non capiva il problema se andavo abitare non lontano dalla casa di famiglia.
Conoscevo l’estremo pudore di mio padre ad affrontare qualsiasi discussione sulla vita privata ma, quella volta, non potevo proprio lasciar perdere.
Lo guardai dritto negli occhi e gli dissi che lui era una persona intelligente e che, perciò, mi stupivo che non capisse che a soli ventisei anni era semplicemente assurdo che io non potessi avere altri uomini, e non solo, che: “li avrei cambiati come i guanti”.
Gli dissi proprio così.
Non so come trovai il coraggio di spingermi a tanto, ma ero davvero furiosa.
Mio padre impallidì come non mai e mi rispose:
Fa tuto queo che te voi, basta che to mama ea no’ la sápia gnente. E gnanca mi. E, te prego, che sia l’ultima volta che parlemo de ste robe! (“Fai tutto quello che vuoi, basta che tua madre non ne sappia nulla. E neppure io. E, ti prego, che sia l’ultima volta che facciamo questi discorsi !”).
E fu la prima e anche l’ultima volta.
Insomma, mi dichiarai d’accordo con lui, a patto che potessi abitare non vicino alla famiglia e che non dovessi avere l’incubo di visite genitoriali improvvisate.
Mio padre, allora, mi trovò una casa lontano dalla loro e ad un affitto davvero irrisorio.
Così mi sistemai in un’ala di in un vecchio palazzo assai fatiscente e abbandonato da tempo, senza nemmeno il riscaldamento e con un bagno antidiluviano, pressoché inservibile.
Per comunicare, usavo una cabina telefonica a quasi un chilometro da casa.
Siccome non disponevo affatto di mezzi per restaurare quell’alloggio malandato, accettai che mio padre mi aiutasse a ridipingere i muri delle stanze e alcuni vecchi mobili. Mi fece anche di sua mano un approssimativo impianto elettrico, installò una stufa a legna e, in seguito, visto che avevo rischiato di morire soffocata perché il camino non tirava, la sostituì con una a gas.
Ci pensò poi lui a tenere mia madre lontana da casa mia; mio padre ci venne solo per aiutarmi a rendere quasi abitabile quella decrepita dimora e poi non più.
Rinunciavo volentieri ad ogni comodità pur di sentirmi libera.
Andavo io a trovare i miei genitori e mai viceversa.
I rapporti tra me e lui ritornarono ad essere come erano sempre stati, ad eccezione di quei pochi minuti che durò il nostro unico scontro: cordialissimi.
21. Mio padre e la libertà.
Ma mio padre e mia madre come si erano conosciuti?
Avevo già accennato che era stato il fratello minore di mia madre, il delizioso zio Mario, a presentarli.
Ma è interessante anche la location e soprattutto l’occasione.
S’incontrarono in una delle piazze centralissime di Padova – probabilmente Piazza delle Erbe – ad un comizio comunista.
Erano gli anni del primissimo dopoguerra e il fratello maggiore di mia madre (mio zio Gino), era deputato – e in seguito ministro – della più famosa forza di centro e fu tra i Padri Costituenti.
Allora il fermento politico era vivacissimo – oggi inimmaginabile – per cui era normale che si andasse ad assistere agli appuntamenti pubblici anche di un partito avversario.
Mio padre non era assolutamente un nostalgico del Ventennio, ma non era nemmeno di sinistra, per cui scelse il partito di centro, ma senza esserne mai un sostenitore fanatico e divenendo, negli anni, un suo elettore sempre più tiepido.
Torniamo al 1946.
Mia madre assistette ad uno scambio verbale tra un comunista sfegatato e mio padre che spiegava pacatamente al suo interlocutore che per lui la cosa più importante era che ognuno potesse sostenere il suo parere senza impedire ad un altro di farlo o senza che nessuno lo zittisse.
In sostanza, sempre secondo la testimonianza di mia madre, per mio padre la “democrazia” era quello.
E mia madre, che non brillava certo per tolleranza, tuttavia rimase impressionata e affascinata dai modi urbani e dal garbo di quel piacente giovanotto.
Ora, quello che mi chiedevo sempre era se mio padre fosse davvero “democratico”.
Ho alcuni elementi a favore e molti altri a sfavore.
Mio padre, ad esempio, non sopportava che mio nonno Corinto, ovvero il padre di sua moglie, che visse vari anni con noi, si rivolgesse alla nostra collaboratrice domestica chiamandola: “Teresa”. Per mio padre, questo era inconcepibile e, allora, insorgeva:
Eh no, caro missiére, lu la ga da ciamare: “Signora”! (“Eh no, caro suocero, lei la deve chiamare ‘signora’!”). Così, infatti, la chiamava mio padre e il resto della famiglia, facendo andare in brodo di giuggiole la signora Michelón.
Ecco, questo è un punto a favore del suo sentire democratico.
Lo trovavo, invece, altamente “aristocratico”, nel suo essere convinto che il genere umano fosse composto, per la sua maggior parte, da poaréti che no’ i ghe riva (“poveretti, tardi di comprendonio”).
E ancora lo trovavo sanamente “aristocratico” ed “elitario” nei confronti di tutti quei che i xé alergici a la cultura. Magari non lo manifestava a parole alla maggior parte di coloro con cui aveva a che fare, ma io sapevo che lo pensava, anche perché, sempre con me, si sfogava con battute al vetriolo.
Vorrei che fosse chiaro, però, che mio padre non faceva questione di classe sociale ma che il suo essere aristocratico era qualcosa di “metafisico”.
Inoltre mio padre, al di là delle sue blande convinzioni politiche, al di là del suo essere democratico e insieme aristocratico, era prima di tutto un libertario.
Di se stesso soleva dire che assomigliava ad un grottesco personaggio manzoniano.
Si tratta di una vera macchietta, di una caricatura: un “intellettuale”, incapace di arrendersi persino all’evidenza della peste.
Avrete già indovinato chi.
Ebbene, mio padre si concentrava unicamente su una massima di costui, che lo estasiava:
Mi so’ come Don Ferante: no’ vojo “né padroni né garzoni”! (“Io sono come Don Ferrante: non voglio ‘né padroni, né garzoni’!”).
Infatti, lui non era minimamente autoritario e non amava affatto comandare ma, d’altra parte, non tollerava che qualcun altro si sognasse di imporgli la sua volontà.
Finita l’università, io mi appassionai al nascere di un piccolo partito che si batteva per affermare diritti civili che avrebbero svecchiato l’Italia da una cappa di perbenismo e di clericalismo.
Era il partito radicale.
Ci fu, ad esempio, un referendum che tentò invano, nel 1974, di abrogare la legge sul divorzio (passata nel 1970) e i radicali, ma anche i cattolici illuminati – che allora esistevano! – si batterono perché questo non avvenisse.
Mio padre non si scandalizzava per niente che io fossi fermamente contraria a tale abrogazione, mentre mia madre faceva immani scenate giudicandomi altamente immorale.
Al che, mio padre, per il quieto vivere, mi prendeva da parte e mi diceva:
Dighe a to mama che te voti per l’abrogassión e po’ nell’urna fa queo che te vói, parché se no to mama no’ ghea mo(e)a più! (“Dì a tua mamma che voti per l’abrogazione e poi nell’urna fai quello che ti pare, sennò tua mamma non la smette più!”).
Io mi arrabbiavo con lui e gli dicevo che era un bell’ipocrita e che si vergognasse ad incitarmi alla menzogna.
Ma, se c’era una persona aliena dal veleno della mia epoca, ossia l’ideologia, quello era mio padre.
Sicché, lui mi rideva in faccia e cercava di smontarmi col suo realismo:
Cossa sarà par ti, pico(e)a, dire ‘na busía? Tanto to mama no’ ea ragiona e mi saría anca beo che stufo de tute ste tragedie che la fa! (“Che fatica sarà per te, piccola, dire una bugia? Tanto tua madre non ragiona e io sarei anche proprio stanco di tutte queste tragedie che lei fa!”).
La guerra di posizione continuò per giorni: mia madre, ad un certo punto, si mise a letto dichiarando che aveva deciso di lasciarsi morire dal dispiacere per avere una figlia come me.
Io tenni duro fin che potei, con mio padre che mi guardava esasperato e insieme con commiserazione.
Lui, allora, tirò fuori il suo asso nella manica:
Se te brusa dire ‘na busía, fa(e)o par mi! (“Se ti dispiace dire una bugia, fallo per me!”).
Non vi dico come andò a finire.
Potete immaginarvelo.
C’era poi un’altra battaglia portata avanti dal partito radicale: quella dell’antiproibizionismo.
Il centro storico della mia città, in quegli anni, era pieno zeppo di tossicodipendenti che erano piuttosto fastidiosi, sia per lo spettacolo che davano, sia per le minacce che talvolta esercitavano sui passanti.
Mio padre, allora, se ne uscì con una frase sorprendente:
Basta! La droga i ga da comprarsela dal tabaccaro! Cussì almanco ‘sti ostrega de drogai e anca tuti ‘sti spaciatori i ga finio! (“Basta! Devono potersi comperare la droga dal tabaccaio! Così almeno questi benedetti drogati e pure tutti gli spacciatori la smettono!”).
Mia madre s’indignava e gli obiettava che così sarebbero morti un sacco di poveri ragazzi, al che, mio padre ribadiva senza scomporsi:
Se uno vóe drogarse, ga da esere libbaro de poderlo fare sensa tante complicassión e sensa rompare e scatoe a nissun! Se po’ el sciopa, fati sui! Ansi, mejo! (“Se uno vuole drogarsi, deve poter essere libero di poterlo fare senza tante complicazioni e senza rompere le scatole a nessuno! Se poi muore, sono fatti suoi! Anzi meglio!”).
Seguivano ulteriori rimostranze di mia madre.
Sono passati decenni e noi siamo sempre più immersi in un bagno di moralismo, così continuiamo ad aver a che fare con la criminalità organizzata, invece di stroncarla alla radice: mio padre, come sempre, era all’avanguardia!
In conclusione, proprio questo mélange paradossale d’istanze libertarie e di cinismo era tipicissimo di mio padre.
22. Mio padre e la depressione.
Voglio concludere con un aneddoto che mette in luce in maniera eclatante la grandissima “sanità psichica” del mio genitore, ma non solo quella…
Sinora non ho quasi parlato di mio fratello Giovanni, con cui ultimamente vado molto d’accordo.
Non fu affatto così negli anni in cui lui era bambino e, meno che meno, quando era adolescente.
I nostri caratteri allora cozzavano violentemente; eravamo davvero cane e gatto. Inoltre, lui era il cocco di mia madre, sempre pronta a scusarlo e a rendergli la vita facile, mentre con me lei cercava ogni pretesto per litigare, anche quando io non ne avrei avuta nessuna voglia.
Non a caso, ci siamo riconciliati tra fratelli quando mia madre passò a miglior vita.
Mio fratello è adesso una persona solare che ammiro molto perché affronta con estremo coraggio e serenità tutta una serie di grossi problemi, di cui non intendo parlare qui.
Da adolescente, invece, tendeva ad essere l’esatto contrario: piuttosto cupo e depresso.
Mio padre non gli perdonava innanzi tutto di non aver voluto fare il liceo ma un istituto tecnico e, in generale, di aver pochissima voglia di studiare.
Sia chiaro che a mio padre non interessavano per niente i singoli voti, ad esempio, non si scomponeva mai quando io ne prendevo di bassi nelle materie che non mi piacevano: perché era memore che nemmeno lui era stato uno studente modello e che aveva amato dedicarsi solo a quello che più gli ispirava.
Ma mio fratello, da ragazzo, dello studio non ne voleva sapere in toto.
Giovanni era tra i sedici e i diciassette anni quando, dopo aver smesso di frequentare la scuola, cominciò a starsene, ogni tanto, confinato in casa, per lo più rinchiuso nella sua stanza, talora al buio, e sempre di umore tetro.
Ora, dovete mettervi nei panni di mio babbo che, giusto a quell’età, aveva perduto il suo di padre e che aveva poi dovuto affrontare, ancora giovane, immense privazioni in un campo di internamento: che empatia e che comprensione poteva avere per il disagio esistenziale di mio fratello, che in confronto a lui da ragazzo, aveva una vita molto più facile?
Nessuna.
Inoltre, mio padre, come già vi ho accennato, costituzionalmente non sopportava i musi lunghi, le lune per traverso e, di conseguenza, le relative preoccupazioni accorate di mia madre: per lui erano tutte inutili seccature.
Accadde, che mentre si svolgeva una delle clausure di mio fratello, venimmo a sapere che un suo coetaneo si era impiccato.
Si trattava di un ragazzo cosiddetto “modello”: andava benissimo a scuola e in famiglia si comportava in maniera corretta.
Ora, per una strana coincidenza, mia madre conosceva la madre del suicida, io ero stata in classe con la sorella e, cosa più grave, Giovanni aveva frequentato quel ragazzo nel Patronato della Parrocchia.
Mia madre seppe della disgrazia per prima, convocò subito mio padre e la sottoscritta ingiungendoci, sottovoce, di non farne parola a tavola con Giovanni, il quale per il momento se ne stava ancora chiuso nella sua stanza, da cui, quel giorno, non era ancora uscito.
Allora non esistevano certo i cellulari e i miei non comperavano nessun quotidiano locale, sicché mia madre, si mise a piantonare il telefono a parete, sito in corridoio davanti alla camera di mio fratello. Insomma, cercò di organizzare un perfetto “silenzio stampa”.
Sperava, così, che Giovanni non venisse a sapere nulla del suicidio. Perché quello che lei temeva di più era che un simile atto estremo inducesse il mio depresso fratello, per contagio, a vagheggiare di fare altrettanto.
Mio padre stava già sbuffando.
Non so come, la funesta notizia giunse lo stesso a mio fratello e, quando lui si presentò a tavola, avvolto nel più totale umor nero, le prime parole furono per lodare il coraggio del suo amico. Non solo: si spinse a dire che quel ragazzo era un esempio.
L’atmosfera, ancor prima dell’ingresso di mio fratello in cucina, era già assai pesante e si fece ancora più plumbea e funerea dopo una sortita del genere.
Ovviamente, mia madre, con una voce rotta dal pianto, implorò mio fratello di non dire cose simili.
Io spiavo mio padre e vedevo che lui non ne poteva proprio più di tutto quell’andazzo da tragedia, infatti, scoppiò nell’uscita più sorprendente e terribile che abbia mai sentito e che mai sentirò:
Cópate, Nino! Cópate! Ma ricordate ch’el primo dì pianzo, el secondo anca, ma el terso canto el gloria! (“Ammazzati, Nino! Ammazzati! Ma ricordati che il primo giorno piango, il secondo pure, ma il terzo canto il gloria!”).
Cerco di darvi una vaga idea del dirompente effetto fonico di tale formidabile battuta. Che, se mettiamo tra parentesi il dramma che in essa si giocava, era innanzi tutto un autentico capolavoro a livello teatrale.
Dovete immaginare la voce di mio padre in un crescendo di esasperazione, con una pausa mentre passa dall’invito esplicito al suicidio all’ammonimento perentorio di quel ricordate! Altra pausa tra il primo il secondo giorno e una sottolineatura di gran concessione su quell’ anca, il tutto coronato con tono di sollievo esultante nel finale.
Io rimasi travolta dall’ammirazione: avrei voluto baciarlo in fronte.
Non solo: sotto sotto, avevo anche una gran voglia di mettermi a ridere, ma mi trattenni.
Ovviamente, mia madre scoppiò in singhiozzi:
Mario! Cossa dísito? Xé to fio(e)o! (“Mario! Cosa dici? È tuo figlio!”).
Mio padre non arretrò e alzò le spalle, come a significare, in primis, che la misura era colma e, in secundis, che tanto Giovanni non si sarebbe mai ucciso.
Insomma, lui lanciò una sfida e, insieme, corse un rischio tremendo, lo fece, però, perfettamente convinto che, così, ogni esito funesto si sarebbe dissolto come neve al sole.
Ed ebbe ragione: da quella volta mio fratello non parlò più di suicidio e il suo umore cominciò a migliorare.
Di questo era capace mio padre!
Note di fonetica
Traslitterare il dialetto padovano è un’impresa ancora più difficile che si trattasse del veneziano. Ad esempio, nel veneziano la lettera “l” è abbastanza simile all’equivalente “l” in italiano, mentre in padovano “l”, davanti ad una vocale, spesso scompare e c’è una debole traccia di una “e”. Ecco perché ho deciso di risolvere, ad esempio, la sillaba “la” con una un “(e)a”, come nel caso di “pico(e)a”.
Rimane la difficoltà di far capire come suoni il corrispondente veneto della terza persona dell’indicativo presente del verbo essere: “xé”, dove il suono “x” assomiglia solo in parte a quello di una “z”
Per il resto, ho messo numerosi accenti tonici nel tentativo, temo vano, di evocare una pronuncia corretta.
Infine, mi è stato obiettato che potevo astenermi dal mettere tra parentesi la traduzione delle battute in dialetto, perché la resa italiana le appiattisce e le banalizza. D’accordo, ma io spero di avere anche lettori non padovani e, soprattutto, non veneti.
Dediche e ringraziamenti
La dedica principale è per i figli di mio fratello: Cecilia e Edoardo. La prima non aveva ancora tre anni quando nonno Mario morì e il secondo non era ancora nato.
Ceci troverà oggi questo scritto tra i regali di nozze, mentre Edo lo conosce già perché ha dato per primo la caccia agli errori di battitura.
Essendo molto distratta e avendo grossi problemi di vista, ulteriori refusi sono stati poi scovati da cari amici: Paolo Felletti, Felice Comello, Franco Chiereghin, Alessandro Tessari, Manuela Scarso e Paolo Roveroni, che ringrazio di cuore per il loro affettuoso sostegno.
Ringrazio mia cugina Lucia Guidorizzi, che mi ha dato per prima l’approvazione del titolo e che mi ha fatto notare alcune piccole ripetizioni, che ho poi eliminato.
Un grazie particolare va a Gabriele Fedrigo per avermi incoraggiato a cominciare a scrivere.
Grazie pure a Nino Calzolari per aver testato la comicità di alcune battute paterne, che gli ho raccontato mentre scrivevo.
Sono grata a mio fratello Giovanni per avermi chiarito dei dubbi circa certi ricordi e soprattutto per non essersi arrabbiato nel leggere l’ultimo capitolo.
Infine, un ringraziamento postumo va a mia zia Gemma Tasinato Guidorizzi (1922-2017) che, con un suo libro di memorie (Il cammino del granchio, Padova, Panda, 2004), mi ha illuminato su mio padre bambino e su mio nonno Giovanni.
(Padova 1 aprile 2023)